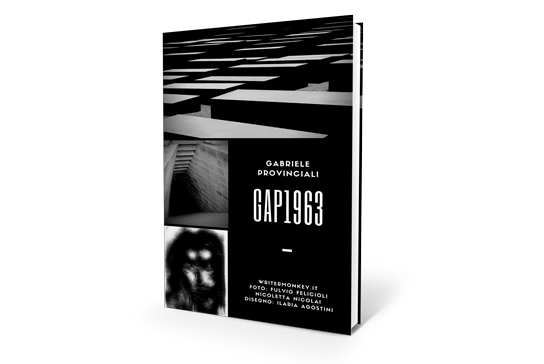Sono le nove di sera del 10 novembre 1943, non ricordo esattamente l’ora, a dodici anni non si porta l’orologio al polso, non lo si portava allora.
È una serata limpida, tiepida, come spesso succede in Riviera anche dopo le festività dei Morti. Io giro tra i tavolini con il grembiule bianco che indosso come una divisa, portando il vassoio con le coppe di gelato sotto lo sguardo vigile di mio padre. Seduti sotto i portici, i soldati tedeschi passano le serate rilassati, forse cercando di dimenticare quella guerra che in molti non riescono a capire e che li sta rigettando indietro, non la guerra delle divisioni corazzate ma una guerriglia continua in cui i nemici hanno lo stesso volto del garzone che porta il pane in caserma o della ragazza che addocchianno mentre passa e che a volte – non vista – ricambia con un’occhiata.
I nemici sono loro, ma non lo sanno o non vogliono crederci.
Io raccolgo le ordinazioni, ho imparato qualche parola di tedesco e loro di italiano, e quando storpiano qualche verbo mi scappa da ridere, anche se non dovrei perché mio padre non vuole. Ma sono quasi tutti ragazzi, poco più grandi di me, li vedo giocare a pallone nel campetto vicino alla loro caserma e senza divisa non sono differenti da noi. E poi qui è una zona tranquilla, una piccola cittadina e i partigiani non si sono mai visti, o meglio, ci sono e girano in mezzo alla gente e non potrebbe essere altrimenti, perché sono tutti figli, fratelli o sorelle di qualcuno, ma non hanno mai fatto attentati quaggiù e i tedeschi forse sanno ma fanno finta di niente: perché rinunciare a una vita così tranquilla in tempo di guerra?
Recco non conosce la guerra, i suoi cittadini che sono stati arruolati sono lontani e ogni tanto scrivono, da mangiare ce n’è perché le barche dei pescatori di Camogli escono ogni notte e quasi tutti hanno qualche parente con un piccolo orto e qualche gallina.
Recco non è come Genova, che ha subito dei terribili bombardamenti dal mare e dall’aria per le sue industrie il suo porto, a Recco non c’è niente di interessante. Niente a parte il ponte della ferrovia che passa alto sopra le case e che tutti guardiamo con un po’ di preoccupazione.
Adesso due soldati si sono messi a cantare. Lina, la cameriera, che ha diciotto anni, ride anche se non capisce niente, così a me tocca correre per servire tutti, ma non mi dispiace, perché sono figlio del padrone, e i soldi che entrano vanno in cassa.
Poco lontano il mare è scuro, rade lampare sciamano al largo come lucciole su un lago, le onde sciabordano sommesse sulla battigia con un rumore a cui siamo tutti abituati. Una sera come tante, una delle ultima all’aperto prima dell’inverno.
Sto per rientrare con il vassoio vuoto quando d’improvviso mi fermo. Un rumore nuovo si è sovrapposto a quello del mare, un rombo sordo e continuo che sembra venire dal cielo. Adesso vedo che non sono l’unico ad ascoltare. I tedeschi balzano in piedi e abbandonano i tavolini, senza preoccuparsi di pagare. Io vedo mio padre che li guarda allibito, così cerco di fare qualcosa e ne prendo uno per il braccio per fermarlo. Lui mi guarda con gli occhi stravolti. Io non capisco, lui mi indica il mare, no, la spiaggia: «Schnell! Schenll!» mi urla, e mi trascina via di peso.
La gelateria è sul lungomare, sono poche decine di metri e ci troviamo sul bagnasciuga. Il tedesco si ferma e si corica per terra. Io lo guardo, e lui mi fa cenno di mettermi giù. Poi nasconde la testa sotto la sabbia, più profondo che può. In quel momento le bombe cominciano a cadere.
Non so quanto tempo sono rimasto lì, con la testa anche io sotto la sabbia e il culo fuori, sentendo la terra tremare cento, mille, non so quante volte. In quel buio fatto di terrore immaginavo le scene fuori, il frastuono degli edifici che crollano, le urla della gente, ma in realtà non sentivo niente, solo gli scoppi delle bombe. Cosa si pensa quando si sta per morire? Non lo so, forse a dodici anni non si pensa niente, a dodici anni è impossibile morire, oppure è tanto il terrore che ti mangia il cervello e te lo riduce in pappa, così non ti ricordi niente e dopo – se c’è un dopo – ritorni a vivere.
Alla fine tutto cessa. Non come quando finisce di piovere, che le gocce si diradano via via, ma di colpo. Gli aerei hanno sganciato il loro carico di morte e si allontanano indisturbati, non c’è neanche la contraerea, a Recco. Io rimango nella stessa posizione ad ascoltare il silenzio che si è fatto assordante, finché non sento una mano che mi scuote. È lo stesso tedesco che mi ha portato fin lì, anche lui si guarda intorno stranito. Uno dopo l’altro si alzano i suoi compagni dai loro rifugi di granchi. Qualcuno non si alza più: le bombe hanno colpito la città, ma una o due sono finite anche sulla spiaggia. Mi volto verso il nostro bar e non vedo più niente, solo macerie e lingue di fuoco, come in gran parte della città. Lontano comincia ad alzarsi il suono delle ambulanze. Mi alzo e mi scrollo la sabbia di dosso. Scoprirò poi che quel soldato portandomi in spiaggia mi ha probabilmente salvato la vita, e che mettere la testa sotto la sabbia serviva ad evitare che fossero le onde d’urto ad ammazzarti. Mi aggiro come uno spettro tra le rovine, cercando mio padre, ma mi dicono che è scappato sotto al ponte e si è salvato. Non hanno avuto la stessa fortuna mia madre e mia sorella piccola.
Non abbiamo più niente: casa e bar sono distrutti. L’unica cosa ancora in piedi, più o meno danneggiato, è il ponte. I tedeschi lo ripareranno tutte le volte che verrà colpito, e alla fine saràe rimasto solo lui, lui e il quattro per cento delle case. Ma i cittadini di Recco dopo quella notte non avrebbero più pagato un tributo di sangue, sono scappati tutti nelle campagne, i più fortunati da qualche parente a Camogli.
Oggi cammino per una città completamente nuova, costruzioni moderne hanno preso il posto di quelle rase al suolo, molti come me hanno perso tutto, altri sono stati più fortunati e si sono arricchiti, altri ancora sono morti. I tedeschi sono ritornati nella loro terra e a volte immagino che tra i tanti turisti ci sia anche qualcuno di quei soldati, quelli che insieme a me hanno messo la testa sotto la sabbia. Quei soldati venuti come alleati, partiti come nemici, ritornati con le loro grosse Mercedes e Bmw e le famiglie, che indugiano a mangiare il gelato seduti ai tavolini del lungomare e osservano i loro bambini biondi giocare tra le onde. Forse, quando nessuno li vede, lasciano scivolare la sabbia tra le dita, ricordando le sensazioni di quella notte che sembrava non finire mai.
O forse no, forse sono solo io a farlo ancora oggi.