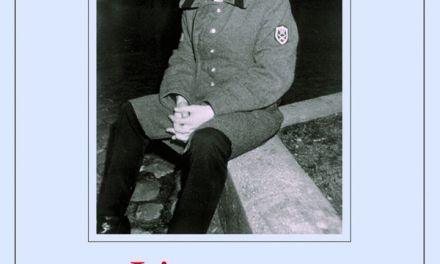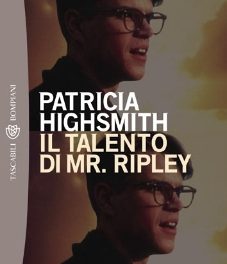IL MESTIERE DI VIVERE, DI CESARE PAVESE Crescendo i nostri gusti cambiano. Non siamo più i lettori di un tempo. Cosa cerchiamo in un libro? Forse non più la velocità, l’energia, l’estro a qualunque costo, ma un amico, qualcuno che ci tenga compagnia dopo una lunga giornata. Uno scrittore che sentiamo di conoscere, come una persona, anche se è lontanissimo da noi, nei luoghi e nel tempo. Per questo ci sono autori che ci rimangono accanto, per tutta la vita, altri di cui finiamo per dimenticarci. Non sono necessariamente i più bravi, ma partecipano delle nostre gioie, dei nostri stessi dolori. La loro malinconia ci appartiene. Nelle loro pagine non cerchiamo un altro mondo, ma quello che viviamo, adesso, ed è inciso dentro di noi. Difficile, quindi, ritrovarlo in un Ulisse, in un Infinite Jest; difficilissimo rivederlo in certe opere di Calvino, nei suoi arabeschi, quando appare sullo sfondo l’immagine di un uomo superiore, tutto votato alla morale adamantina, impeccabile, limpidissima – o almeno così sembra – dello scrittore impegnato, comunista (certamente parecchio furbo). Molto più facile specchiarsi in un Pasolini (da qui forse, più ancora che nei suoi lavori, la sua immensa fortuna) e soprattutto in un Pavese.
Cesare Pavese è stato innanzitutto un uomo, prima ancora che un artista. Una creatura ibrida, malata, sempre “di casa fra due mondi”, come il Tonio Kroger di Thomas Mann. Un egocentrico, eternamente indeciso fra la strada dell’Arte e quella dell’impegno, del piacere o del dovere, fino al punto di nascondersi, durante la Guerra, restando così con un senso di colpa, da espiare – senza rimedio – all’interno del PCI, quando ormai era troppo tardi. Un eterno ragazzino, capace di infatuarsi di una ballerina, o una starlette, dopo mesi dedicati a Joyce o Melville. Un provinciale, messo ai margini di quel “bel mondo” torinese, a cui però segretamente aspirava, fra spettri di decadenza e fantasmi fin de siècle. A volte fatuo, mellifluo, irritante addirittura, nel suo essere verboso e fin troppo incline a certe debolezze, ha il grande merito di non essersi mai nascosto, anzi, di aver applicato su di sé tutta la sua furia analitica, fino a diventare il più grande nemico di se stesso.
Come ne “Le False Coscienze” di Marchesini, nelle pagine di Pavese – in particolare nelle Lettere, e nei suoi diari, conosciuti come “Il Mestiere di Vivere” – è in atto una coscienza scissa, sdoppiata, che pensa e anche analizza se stessa, in un gioco di specchi, di rimandi, di citazioni e note a margine, fino alla completa paralisi. Così non ci viene nascosto nulla, di lui, neanche i dettagli più tristi, quelli che svelano gli eccessi del suo ego. Ma anche questo è grande. Questa forma di auto-consunzione, se da un lato è stucchevole, dall’altro richiede una forza eccezionale, tanto è difficile “sentire” in quel modo. Crescendo tutti ci lasciamo alle spalle quella parte di noi stessi. Quella che viveva di impressioni, emozioni, dolci follie, senza mai preoccuparsi del futuro. Oggi no, ci sarebbe impossibile, come fare il morbillo a quarant’anni. L’impatto sarebbe devastante. Ma in una giornata piovosa, dopo ore di ufficio, è bellissimo ritrovarsi in ciò che siamo stati, e dunque in Pavese.
Così, se penso a Pavese, non mi vengono in mente le sue opere – né i romanzi né le poesie, e tantomeno i saggi – ma la sua vita di uomo, con i dolori, i pensieri, le cose grandi e folli di ogni giorno. Il suo lascito di artista non è grande, mentre nei suoi diari pulsa qualcosa di eterno. L’essere uomo di Cultura, dedito all’Arte, anche in un mondo che palesemente se ne frega, che non chiede altro se non vivere, nel senso moderno del termine, cioè produrre, consumare, divertirsi, e via così, fino alla prossima. Andare avanti, quando qui si rimane immobili, prigionieri di forme circolari. Comunque vada, quale che sia il giudizio su quest’uomo, è innegabile che abbia lasciato un segno. Perché ci ha provato sempre, fino all’ultimo, e solo nell’ineluttabile ha conosciuto la sconfitta. Allora, di fronte al suo peggior nemico – Cesare Pavese – ha alzato la mano su di sé. Si è amato e odiato a morte. Per noi deve essere come un fratello – qualcuno a cui vogliamo bene, senza remissione. Gli dobbiamo tantissimo, soprattutto nei giorni di pioggia.