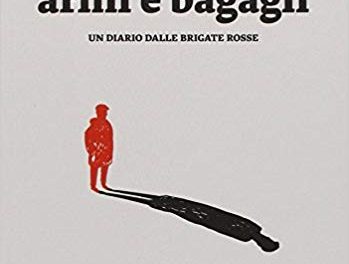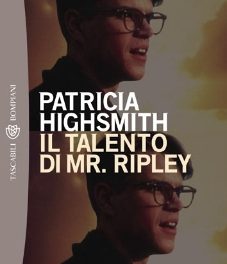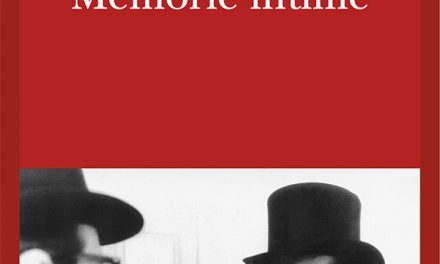RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “Titolare” del loro trattamento è Writer Monkey APS, che ha sede in via Ciceruacchio 7 – 00015 Monterotondo (Roma) Italy.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono servizi erogati su Data Center posizionato presso la sede di Writer Monkey, localizzato ad Amsterdam (in ottemperanza alla direttiva 95/46/CE), in Business Continuity/Disaster Recovery, e con il presidio continuo degli amministratori di sistema di Writer Monkey aps.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 23 giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari per l’erogazione del servizio richiesto. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati propri personali. Tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Una volta espletate le specifiche finalità di Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Writer Monkey aps ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società per attività strettamente connesse e strumentali all’operatività del servizio, come la gestione del sistema informatico. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (brochure, materiale informativo, libri, riviste ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati salvo previsione contrattuale o di legge, ovvero salvo specifico consenso richiesto all’interessato. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; c) ciò sia necessario per adempiere a richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, ai sensi degli articoli da 15 a 21. del Regolamento (UE) 679/2016, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679.
MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
Writer Monkey aps verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, la rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall’evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.
DOMANDE, RECLAMI, SUGGERIMENTI E ESERCIZIO DEI DIRITTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy, sul modo in cui la nostra associazione tratta i dati personali, nonché per far valere i propri diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Writer Monkey aps Via Ciceruacchio, 7 – 00015 Monterotondo (Roma) Italy oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo writermonkeymsil@gmail.com
COOKIES POLICY
Per rendere la navigazione più funzionale a volte è necessario salvare alcune informazioni sul tuo dispositivo, ad esempio il tuo pc o smartphone. Queste informazioni non possono essere utilizzate per per identificarti personalmente. Esse servono soltanto a migliorare il servizio.
Ci sono due tipi di cookie che puoi trovare usando questo sito:
Cookie proprietari: questi sono i cookie controllati da noi e usati per fornire informazioni sull’uso del nostro sito. Tra questi l'esempio tipico è l'autenticazione di sessione, che serve ad evitare di dovere effettuare il login più di una volta nella stessa sessione di utilizzo del browser.
Cookie di terze parti: questi sono cookie che si trovano in strumenti web di società esterne che usiamo per migliorare il nostro sito. Un esempio sono i cookie di Google Analytics, usati per ottenere informazioni su come i visitatori usano il nostro sito. I cookie salvano informazioni in forma anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da quale sito provengono gli utenti e le pagine da loro visitate.