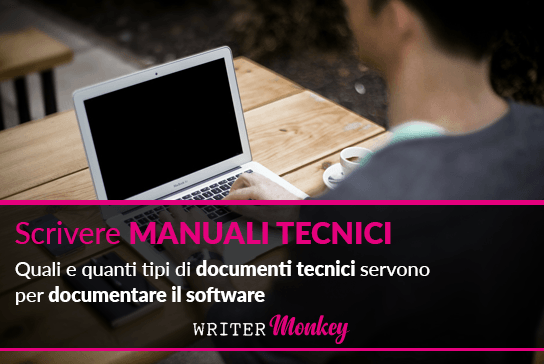«Quello che devi fare è una scansione cerebrale completa».
Jack annuì stancamente.
«Ne ho fatta una la settimana scorsa, ho la registrazione in ufficio».
«Non va bene, ci vuole una scansione molto più dettagliata. C’è una struttura in Massachusetts, il General Hospital Neurotechnology Center, dove si è elaborata una nuova tecnologia di imaging, con una risoluzione estremamente avanzata rispetto a quelle correnti. Il Center, non più nella fase sperimentale, è alla continua ricerca di volontari, malati cerebrali gravi o terminali, per un avanzamento negli studi sulle mappe neuronali e perfezionare ulteriormente il suo già sofisticato sistema di rilevamento».
«Massachusetts?» chiese Jack scostandosi la pezza gelata dalla fronte per versarsi un altro bicchiere di whisky «non c’è niente di più vicino?».
«No» rispose secca la voce «“L’Excavator” questo il nome che il macchinario si è guadagnato per la sua straordinaria capacità di scavare nei recessi più remoti delle aeree cerebrali, è unico prototipo, e siamo stati noi, attraverso tecniche subliminali, a permetterne la realizzazione nella totale inconsapevolezza degli ingegneri del Center. Di Excavator non ce ne sono altri sulla faccia della terra».
La voce tacque il tempo necessario per far digerire a Jack l’inevitabilità di quel viaggio, e aggiungere poi con marcato disprezzo: «Continuare ad ubriacarti non ti farà passare il mal di testa».
«Se devo morire tra poco tanto vale che lo faccia con il fegato a pezzi e non nel pieno delle mie facoltà mentali».
«Se è questo che vuoi… allora stiamo perdendo solo tempo. Ritiriamo la proposta»
Il tono, tagliente e risoluto, lo precipitò di getto nella realtà da cui, con quell’ubriacatura forzata, aveva cercato di fuggire. Si riscosse, improvvisamente lucido, per opporsi a quella minaccia che lo avrebbe privato della sua unica, tragica chance di sopravvivenza, seppure ai suoi come?, dove?, quando? la voce non avesse saputo dare risposte definitive. Avere un qualche indizio concreto gli avrebbe permesso, invece, di districarsi con più lucidità nel caos che lo aveva travolto e che non coinvolgeva lui solo, perché nella sua vita c’era anche Carol. Non tenerne conto significava disconoscerla, e questo lui non lo avrebbe mai fatto. Le doveva delle spiegazioni, trovava intollerabile che lei, al suo risveglio, non trovandolo vicino potesse pensare ad un abbandono. La voce avrebbe dovuto dargli il tempo di mettere le cose a posto.
«No, aspetta» gridò, improvvisamente lucido, «stiamo andando troppo veloce. non credi? Mi stai chiedendo… no, mi stai imponendo di fare tabula rasa di tutto quello che fino a ieri è stata la mia vita. Cancellare tutto, anche Carol, i miei sentimenti e i miei doveri verso di lei. Ti sto chiedendo solo un po’ di tempo per sistemare le cose e poi…».
«Ma nessuno di noi ha più tempo, Jack!» tuonò la voce spazientita. «Né tu, né noi, e neppure Carol»
Un pugno allo stomaco quel monito secco che non gli lasciava scampo.
«Se vuoi tirarti indietro fallo ora perché dopo non ti sarà più consentito».
«Ho bisogno di riflettere, e vorrei farlo da solo. Stai fuori dalla mia vita, almeno per questa notte».
«Dodici ore credi sia un tempo sufficiente per la tua decisione?» concesse la voce. «Dodici ore, non un minuto di più».
Fuori cadeva una pioggia persistente, sottile e pungente, con gocce che trafiggevano come spilli. Jack uscì senza curarsi di prendere l’ombrello e raggiunse l’auto che aveva lasciato davanti alla casa. Salì, mise in moto e schiacciò a fondo l’acceleratore, con rabbia. L’auto partì sbandando.
Le strade erano deserte, lucide per la pioggia. I palazzi scorrevano veloci attraverso il finestrino, i tergicristalli grattavano leggermente il parabrezza lasciando strisce di bagnato. Un semaforo rosso. Jack accelerò, superandolo, poi un altro e un terzo, sempre più veloce, finché non si trovò fuori città, sulla strada che portava verso il monte Hood. Lì finiva l’illuminazione e il nastro d’asfalto scompariva nella notte. Si fermò di fronte a quella immensità sconosciuta, accostò sulla destra e picchiò forte le mani sul volante, fino a farsi male, incapace di credere a quello che gli stava succedendo.
Le tempie gli pulsavano e il cuore gli doleva. Un dolore sordo, remoto. Incontenibile. Serrò le dita a pugno per frenare il tremito delle mani, ma il lieve riverbero della veretta d’argento al suo anulare destro, gemella di quella di Carol, penetrò gli occhi e la coscienza con la crudeltà di una lama affilata che gli strappò un muto urlo disperato. Un urlo inudibile al mondo ma non alla voce. Neppure quella disperazione era interamente sua. Niente più gli apparteneva.
Fece inversione guidando piano verso la città, questa volta rispettando gli incroci. Come fu arrivato sul Powell Boulevard vide una figura che passeggiava sulla via pedonale accanto alla strada sotto un vistoso ombrello bianco. Gli stivali alti, anch’essi bianchi e l’ampio spacco dell’impermeabile parzialmente aperto che lasciava intravedere una generosa porzione di gambe non lasciavano dubbi sulla professione della donna.
Anche lei l’aveva notato – era l’unico automobilista che stava passando – e quando lui si fermò lo intese come un invito ad avvicinarsi Jack aprì il finestrino e lei si affacciò all’interno, mostrando il seno attraverso la profonda scollatura.
«Ciao» disse.
«Ciao».
«Passavi per caso da queste parti?», chiese, con un sorriso ironico. «Mi fai salire? Piove».
Jack aprì la portiera e lei scivolò rapidamente dentro. Alla luce della lampadina di cortesia si videro in volto: non era bellaeil viso era segnato. Più vicina ai quaranta che ai trenta, stabilì Jack con un colpo d’occhio, anche se lui non era mai stato bravo ad indovinare gli anni. Le donne, poi, conoscevano mille trucchi per imbrogliare sulla loro età.
Anche lei lo vide: gli abiti bagnati, i capelli gocciolanti e lo sguardo allucinato la posero sulla difensiva.
«Ehi va tutto bene?» chiese, tenendosi pronta a saltare giù dalla macchina.
«Cosa?».
«Mi sembri sconvolto. Ti è successo qualcosa?». Strinse forte la borsetta, che conteneva uno spray antistupro e una pesante pietra levigata racchiusa in un calzino.
«Se te lo dicessi non mi crederesti. Non mi crederesti davvero!».
Il tono era divertito, ma senza allegria. Si capiva che stava mentendo.
«Se vuoi possiamo parlarne …».
«Non sono qui per parlare. Quanto vuoi?» chiese, tirando fuori il portafoglio.
Lei sbirciò il fascio di banconote.
«Duecento dollari una sveltina, quattrocento il servizio completo».
Jack le porse una manciata di biglietti senza starli a contare, che quella fece velocemente sparire nella borsetta.
«Ho una camera nel motel qui vicino» propose, indicando un punto vago nella pioggia.
Jack assentì.
Parcheggiarono nell’ampio spazio interno al motel, sotto la luce livida di alcuni lampioni, vicino ad una fila di alberi spogli. La donna scese per prima e si diresse verso l’ingresso, seguita da Jack. Un assonnato portiere si girò dall’altra parte quando li vide entrare. Lei ritirò la tessera magnetica, uscì sotto la tettoia che circondava l’intera struttura e si diresse verso una porta. Fece scorrere la tessera nella fessura della serratura, che si sbloccò con un click. Come furono dentro le luci si accesero automaticamente, rivelando una camera abbastanza ampia con un letto a due piazze, un piccolo armadio e un tavolino con una sedia. Una seconda sedia era appoggiata al muro. Una porta ascomparsa celava un minuscolo cucinino, con un fornelletto e un’anta di credenza. L’unica finestra, che dava sull’esterno, era coperta da una spessa tenda che schermava la luce.
La stanza disadorna odorava di umidità e di chiuso. E di abbandono. Un luogo di passaggio per le soste frettolose dei commessi viaggiatori, d’incontro per gli amori clandestini e per le prestazioni a pagamento delle prostitute. Quella stanza era il punto di convergenza di un’umanità precaria e allo sbando. Il luogo perfetto per la sua disperazione.
«Il bagno è da quella parte» disse la donna, posando delicatamente la borsetta sul tavolino per non rivelarne il peso.
Jack vi si diresse meccanicamente. Il locale era piccolo, niente più di un lavandino, un wc e una minuscola doccia. Si lavò la faccia e fece il gesto di riavviarsi i capelli, poi rinunciò: non era un incontro galante quello, e la donna che lo attendeva nella stanza da letto non era Carol. Si asciugò sulla salvietta ruvida che odorava di umido e fece ritorno nella stanza. Lei aveva appeso l’impermeabile ad un attaccapanni posto sulla parete e si era già sfilata gli stivali, che aveva gettato in un angolo vicino al guardaroba.
«Arrivo subito» disse, dirigendosi a sua volta verso il bagno.
Jack si lasciò cadere a sedere sul letto. Il condizionatore ronzava irrorando d’aria calda l’ambiente, e il lampadario al neon al centro del soffitto spandeva una luce fredda, irreale.
Una luce da purgatorio, pensò Jack, amaramente consapevole della sua disfatta esistenziale e della sua incapacità ad opporre una qualche resistenza. Non quella notte, almeno. E non in quella stanza.
La donna tornò quasi subito. Prima di coricarsi accanto a lui accese le abat-jour e spense il lampadario. Adesso la luce era più morbida. Meno invasiva. Lui gliene fu segretamente grato.
Davanti a Jack che la osservava si esibì in uno spogliarello. Con gesti studiati si liberò della minigonna, dandogli modo di ammirare la struttura solida dei fianchi e le cosce lisce e ben disegnate. Con movimenti fluidi si sfilò la maglietta aderente come una seconda pelle, che rivelò un seno pieno, abbondante, con i capezzoli turgidi e scuri. Un seno da pin up, di certo opera di un chirurgo plastico. Il minuscolo perizoma sparì sotto la magia delle sue dita, offrendosi, infine, nuda al suo sguardo.
«Ti piaccio?» sussurrò, soffiandogli la domanda sulle labbra.
Lui accennò di sì con la testa, ma avrebbe voluto anche dirle che il suo corpo non corrispondeva al viso. Un divario d’una decina d’anni li separava. Ma non lo disse, consapevole che lei l’avrebbe potuta prender male. Tacque, lasciando a lei l’iniziativa. Non era mai stato con una prostituta né con nessun’altra dopo che nella sua vita era entrata Carol.
Lei, intanto, s’era messa in azione sotto le lenzuola, per emergerne poco dopo affannata e lievemente delusa.
«Mi dispiace ma non ci riesco» disse.
«Lascia stare, è colpa mia, non è serata».
«Possiamo provare più tardi» disse lei in tono incolore. Non era dispiaciuta e non fingeva di esserlo. La sua parcella se l’era comunque guadagnata
Jack si alzò a sedere e guardò l’orologio.
«Devo andare. Grazie per il tuo tempo e… la tua comprensione».
La donna lo guardò colpita. Di solito i clienti attribuivano a lei la colpa dei loro insuccessi a letto. Qualcuno richiedeva perfino indietro i soldi, mentre lui, invece, la ringraziava “per la comprensione” Era il primo che la trattava in questo modo.
«Come ti chiami?» domandò con dolcezza.
«Jack » rispose lui, un po’ stupito da quella domanda
«Io, Dorothy».
Jack iniziò a rivestirsi con gesti impacciati, imbarazzato dalla sua nudità e da quella di lei. Due estranei, nudi nella stessa stanza,che fino all’attimo prima ignoravano persino i rispettivi nomi. Dorothy intuì il suo impaccio dal fatto che lui evitava di guardarla, e allora per toglierlo dall’imbarazzo, sgusciòdal letto e rivestendosi sommariamente si diresse al cucinino.
«Vado a farmi un caffè, Jack. Ne preparo una tazza anche per te».
Non ebbe risposta, ma quando tornò con le due tazze fumanti lui era ancora lì, a guardare dai vetri della finestra, il malinconico chiarore, spruzzato di pioggia, dell’alba.
Dorothy gli toccò un braccio e lui si voltò.
«Grazie».
Sorseggiarono il caffè in silenzio. Jack, quando ebbe finito, continuò a tenere la tazza vuota tra le mani
«Ne vuoi ancora?» chiese lei.
«Grazie» rispose grato, porgendole la tazza.
Aveva creduto di volersene andare da quella stanza e da quella donna, da quella situazione senza senso, ma ora lì invece si sentiva al sicuro, lontano dal suo mondo. Lontano dalla voce. Ma se non aveva dovuto cercare pretesti per andarsene ancor meno ne aveva per restare.
Fu Dorothy a venirgli in soccorso, a fornirgli il motivo per rimanere ancora. Dal cucinino proveniva una musica di sottofondo da dove, seppur tenuto sotto controllo dal volume basso, prorompeva l’urlo afono di Jonny Lang con le note aggressive di “Lie to me”:
Lie to me and tell me everythingisallright
Lie to me and tell me thatyou‘rstayin‘ the night
Tell me thatyou‘llneverleave,
And I’ll just try to make believe
Thateverythingyou tell me istrue
Perché proprio quel brano? Una premonizione? Un avvertimento?
E Dorothy che ruolo aveva in tutto questo?
Forse non lo aveva abbordato per caso, quella notte. Forse…
Mentimi e dimmi che va tutto bene
Mentimi e dimmi che resterai per la notte
Dimmi che non te ne andrai mai
E cercherò solo di far credere
Che tutto quello che mi dici è vero
Nel frattempo lei era tornata con le tazze colme di caffè e si sedette di fronte a lui.
«Ti faccio compagnia» disse.
Jack la guardò. Si rese conto che era la prima volta che lo faceva da quando s’erano incontrati.
Il viso senza trucco mostrava un’età più giovane di quella che lui le aveva attribuito.
I lineamenti marcati ma non rozzi, gli occhi grandi e scuri, la fronte alta dove si disegnava l’attaccatura a V dei capelli di un rosso stinto ma che la ricrescita rivelava bruni all’origine.
«Tutto bene, Jack?» domandò Dorothy, «se la musica ti dà noia la spengo».
«No, mi piace Jonny Lang. L’ho conosciuto di persona, tanto tempo fa».
«Ma dai!».
«Davvero. Facevo il servizio medico a Minneapolis durante il concerto della Kid Jonny Lang & the Big Bang, era solo un ragazzino».
«Sei un medico, allora».
«Già». Per un momento i suoi pensieri furono proiettati fuori dalla stanza, in quel passato dove lui faceva il medico e aveva conosciuto Jonny Lang, e Carol non faceva ancora parte della sua vita.
«Perché proprio questo brano?» domandò, cercando di dare alla sua voce un tono neutro.
«È il mio preferito. Parla della vita reale e dei sogni che non sempre s’incontrano, di quando si mente, o ci viene chiesto di mentire, per alimentare l’illusione».
«L’illusione e non la speranza?» chiese Jack, ricacciando in gola la nota disperata che lo avrebbe tradito.
«L’illusione» ribadì decisa Dorothy, «se avessimo ancora una speranza non mentiremmo a noi stessi e neppure chiederemmo a nessuno di mentirci».
Jack la fissò stupito: «Sei una donna intelligente, perché fai questo lavoro?».
Lei sorrise, indulgente. Quella domanda se l’era sentita fare più di una volta, come fosse nell’ordine naturale delle cose che una prostituta dovesse essere stupida. Nascere con le stigmate della puttana: un destino irreversibile, senza possibilità di riscatto. Idioti! La sua era stata una scelta ponderata e di cui non s’era pentita.
«Perché mi sento libera e guadagno bene. Molto meglio che fare l’operaia in una fabbrica o la commessa in un negozio, in piedi dalla mattina alla sera a farmi dare delle pacche sul culo dal padrone e stare zitta per non farmi licenziare. Almeno così chi vuole toccarmi il culo deve pagare per farlo» spiegò paziente. Non c’era astio né ironia nella sua risposta. Semplicemente ribadiva i motivi della sua scelta.
Jack la guardò dubbioso, immaginando che quella sua spavalderia fosse uno scudo dietro cui proteggersi e all’occorrenza nascondersi. Etichettò Dorothy come una donna molto intelligente che aveva fatto una scelta sbagliata. Se di scelta si poteva parlare.
«Non hai mai paura? Non sai chi puoi incontrare né cosa ti potrebbe accadere…»
Lei gli sorrise enigmatica: «Perché Jack, tu sai esattamente cosa ti accadrà nelle prossime ore?».
Aveva posto la domanda in tono di sfida, ma le era parso che lui fosse impallidito, e così s’era sentita in dovere di spiegare: «Portland è una città tranquilla ma non sono una sprovveduta e prendo le mie precauzioni». D’istinto i suoi occhi andarono alla borsetta e al suo contenuto: lo spray antistupro e la pesante pietra racchiusa nel calzino.
Jack finì di bere il suo caffè: era giunto il momento di andare, non aveva più alibi per restare. Guardò verso la finestra. Aveva smesso di piovere e una lama scialba di sole tentava di aprirsi un varco nel denso viluppo di nubi. Una speranza o un’illusione quella falce di sole? Avrebbe voluto chiederlo a Dorothy ma non lo fece. Credeva che qualunque fosse stata la sua risposta si sarebbe avverata.
«Devo proprio andare» disse, più che altro a sé stesso.
Lei non cercò di trattenerlo, non era nella sua natura, ma sulla soglia gli mise in mano un fogliettino: il mio telefono, caso mai avessi bisogno di un caffè all’alba.
Uscì nella strada socchiudendo gli occhi per proteggersi dalla luce metallica del giorno. Non aveva sentito chiudersi la porta, così si voltò indietro e vide Dorothy che lo guardava andare via.
Mise in moto e prima di partire lanciò un’occhiata dallo specchietto retrovisore, ma lei non c’era più.
All’ospedale non c’erano novità di rilievo: Carol era sempre in coma indotto. Jack parlò con il neurologo di turno.
«Non sappiamo quando e come la sua fidanzata si risveglierà» disse «né se il suo cervello ha riportato lesioni a causa dell’arresto cardiaco. La violenza della scossa non sembra aver procurato danni scheletrici, come a volte accade nel caso di folgorazioni così violente, ma dovremo fare una risonanza magnetica full body per esserne certi. Tuttavia dai riflessi spontanei agli arti inferiori lo escluderei».
Un discorso asettico, avaro di certezze e colmo di dubbi. Un discorso onesto, essenziale, circoscritto, nell’incertezza di tutto quello che di buono o di cattivo sarebbe potuto avvenire.
Quante volte aveva fatto anche lui discorsi identici e con lo stesso distacco emotivo dissimulato nella terminologia medica? Mantenere le distanze per non rimanere troppo coinvolti, era quello il comportamento a cui conformarsi quando l’esito era incerto, per non indurre a sperare o a illudersi su quello che sarebbe potuto accadere. Per le guarigioni c’erano i sorrisi e per le morti le lacrime. Per i pazienti come Carol, sospesi tra i due confini, c’era solo l’arida competenza.
Jack ascoltava attento, facendo appello all’esercizio a lungo praticato della sua professionalità, ma questo non bastò ad impedire alle sue mani di tremare e agli occhi di inumidirsi.
Il neurologo se ne avvide e in un moto d’empatia gli batté amichevolmente una mano sulla spalla.
«Abbia fiducia e speri, dottor Longshire, la sua fidanzata è in buone mani».
Jack entrò nella corsia dove giaceva Carol e restò per alcuni minuti al suo capezzale. La sua espressione era serena, i capelli sciolti sul cuscino e l’espressione lievemente imbronciata, sembrava dormire.
Jack fu invaso dalla tenerezza. Le sfiorò una mano, per confortarla della sua presenza rassicurarla del suo amore. Le rimase vicino fino a quando un’infermiera lo invitò ad uscire perché quella era l’ora delle pulizie. Allora si chinò su di lei, scostando con delicatezza una ciocca bionda dalla fronte per deporvi un bacio. Sulla porta si voltò un’ultima volta a guardarla.
Aveva smesso di piovere e tra le nubi sfilacciate filtrava la luce del mattino. Infilò le mani in tasca e il ruvido foglietto di Dorothy gli frusciò tra le dita. Lo tenne un momento stretto nel pugno e poi lo gettò via. Vide l’inchiostro azzurro scolorire nell’acqua della pozzanghera dove lui l’aveva gettato.
Anche quell’ultimo legame era stato reciso.
A casa staccò il telefono e silenziò il cellulare: aveva assoluto bisogno di dormire. Di lì a breve lo attendeva un lungo viaggio dall’altra parte degli USA, direzione Boston.
Prima di cedere al sonno sentì la voce sussurrare: «Jack, hai fatto la scelta giusta».