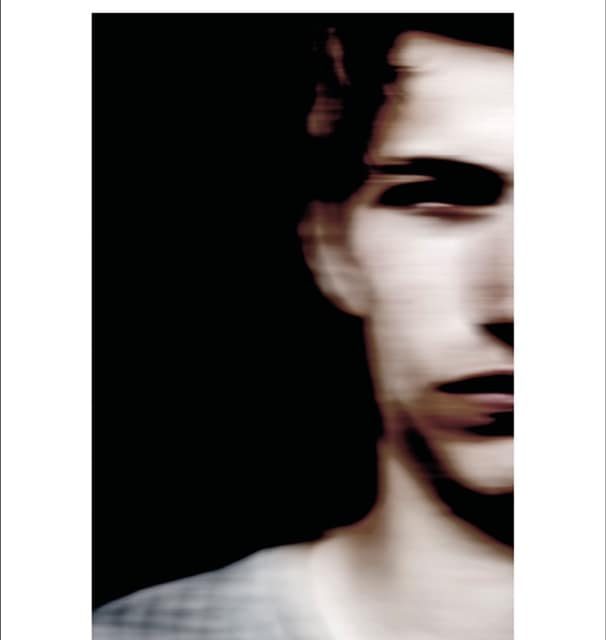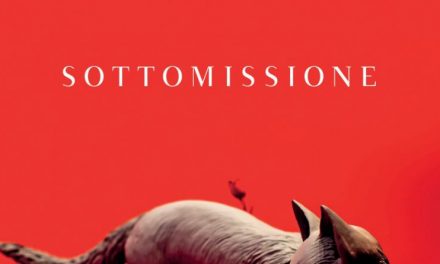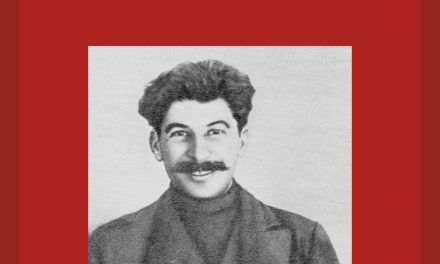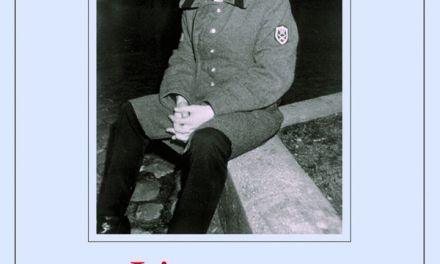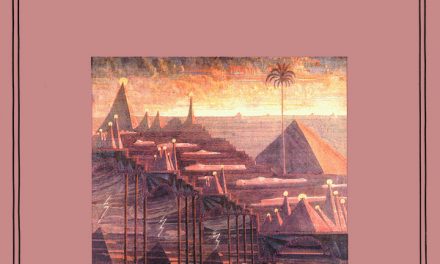Quello che è accaduto qui – Roma, 4 marzo 2016, ma potrebbe essere ovunque e in nessun luogo – è qualcosa di così grande da non avere un nome, e di sicuro non una causa, una spiegazione: è accaduto e basta, e nessuno può coglierne l’essenza.
Dunque nessuno può permettersi di spiegare, e quello che resta da fare – un compito ineludibile non solo per i familiari, le istituzioni, gli uomini di buona volontà, ma soprattutto per uno scrittore – è quello di fissare il proprio sguardo sui fatti, senza morbosità ma anche senza cedere all’orrore, per determinare i contorni di una storia. Crediamo di conoscerla, ma a furia di ripeterla sembra diventata una favola nera, di quelle che si raccontano fra amici, la notte di Halloween, per provare qualche brivido tutti insieme. Invece è successo davvero.
In un giorno di primavera Manuel Foffo e Marco Prato si sono chiusi in un appartamento al Collatino, guidati dalla perversione verso un’orgia di sesso e cocaina; dopo ore di addiction hanno coinvolto un ragazzo – Luca Varani – che è stato drogato, colpito con un martello, squarciato con delle coltellate e quindi strangolato, con un cavo di gomma.
Nel giro di poche ore Foffo ha confessato il tutto, mentre Prato fingeva di suicidarsi in un hotel del centro, fra le note dell’amata Dalida e qualche boccetta di Minias, sorbita senza troppa fretta. Nelle sue lettere d’addio – forse il particolare più agghiacciante dell’intera storia – pregava amici e genitori di ricordarlo con gioia, e di impiantargli dei capelli nuovi e di smaltargli le unghie, perché al rito della cremazione il suo corpo fosse perfetto, come quello di un divo del cinema muto.
Quale splendida emozione! Era questo che contava alla fine – essere ricordato – e pazienza se aveva scoperto “cose orribili dentro di sé e il mondo” – valeva la pena di festeggiare, un’ultima volta, proprio come negli aperitivi organizzati da lui, da qualche parte del centro, dove si bevevano spritz e mangiavano patatine ma sempre con un certo stile, tipico di chi ha classe. Nessuna parola, nemmeno un accenno né qui o altrove al ragazzo massacrato, quasi fosse un particolare di scena, da ammassare dietro al sipario: a chi frega di un morto, quando l’assassino è un Mito? Di chi ci ricordiamo in Sunset Boulevard? Della vittima o della straordinaria Gloria Swanson, che abbandona il palcoscenico con un’ultima, fenomenale interpretazione? Prato non doveva essere da meno.
Forse questa intima consapevolezza – di essere di fronte a un Assurdo inspiegabile, destinato a restare senza nome – è quella che ha guidato Lagioia nella stesura del libro, sempre unita a una tensione fortissima, incapace di spegnersi se non dopo mesi e mesi di lavoro. E’ lui stesso a raccontarlo, quando nelle prime pagine ci parla della sua vita ai tempi dell’omicidio, e del fatto che nonostante la follia, il clamore, i mille discorsi che si facevano allora – spesso in un mix di dolore e grottesco, di indignazione e fascino morboso – dal canto suo voleva starne alla larga.
Un giornale era arrivato a proporgli un reportage, ma non gli interessava – almeno così diceva – perché voleva lavorare al suo libro, e non pensare a niente. Solo che a uno scrittore non è dato scegliere.
Soltanto ai mediocri è concesso di pianificare, di mettersi a tavolino e progettare un libro, proprio come si farebbe con una casa o una macchina o qualsiasi altra cosa, mentre agli artisti – o chi almeno ha un goccio d’Arte nelle vene – spetta un destino affatto diverso, di essere trascinati dall’ispirazione, e così anche in questo caso. Il romanzo di prima ormai non esisteva più, lo scrittore doveva arrendersi alla verità: che gli piacesse o meno, doveva scrivere di questa storia, farla sua.
Ed ecco “La Città Dei Vivi” – un’opera che è destinata a lasciare un segno, per molti anni a venire. Ne sono convinto proprio perché al di sotto di essa – nella sua radice, come un inchiostro invisibile – sta nascosta la consapevolezza di cui parlavo qui sopra, per cui l’autore non cede mai né alla vanità né all’estetismo, o tantomeno alla retorica; Lagioia non vuole incantarci con una prosa fascinosa, non tenta volteggi o prodigi di stile, ma si concentra fin da subito sulla Verità, che appunto non può mai essere declamata o spiegata, ma soltanto mostrata: tratteggiata con parole nude e spoglie, con il massimo rispetto per la tragedia accaduta laggiù, all’Inferno, a un ragazzo che aveva poco più di vent’anni. Questa scelta morale si rivela efficacissima anche sul piano estetico, dando all’opera una compiutezza esemplare, da grande romanzo.
Quasi subito si viene catturati da una prosa che non concede alcuno spazio alle digressioni, ai tic linguistici, alle pose da fenomeno, alle spiegazioni para-filosofiche e nemmeno a quelle bambinesche incursioni nell’Io che sono purtroppo la cifra di molti libri italiani – almeno quelli che si pongono come “letterari”, e finiscono per sembrare ridicoli. “Bisogna fare il suo mestiere di uomo” diceva Charles Péguy, e anche lo scrittore deve svolgere il suo lavoro, con estrema umiltà: solo così si può arrivare al nocciolo delle cose, mai come ora tanto oscure e aggrovigliate.
Difatti il passaggio successivo implica quasi subito una domanda: perché? Perché è successo? Riguardo a questo, il libro sembra esplodere di voci: per qualcuno l’omicidio è chiaramente un effetto del consumismo, di una cultura ormai basata esclusivamente sui soldi e l’apparenza, per altri una questione di classe (“quei bastardi figli di papà, stronzi radical chic”), c’è chi dà la colpa alle droghe e chi alla follia latente (“erano disturbati”), mentre non si può sorvolare sull’omosessualità repressa (Foffo si vergognava di essere gay) o sul fatto che Prato voleva cambiare sesso, e che dire di Roma? Di questa Roma, magnificamente tratteggiata da Lagioia come uno sfondo scabro, lugubre, abbruttito, quasi una necropoli sopra alla quale scalciano i vivi, solo in attesa di essere trascinati in basso, nell’abisso dei morti senza nome… forse solo qui poteva succedere, o forse no, loro non c’entravano niente con nessuno, era soltanto due pazzi, e quelli si sa, si trovano ovunque…
Ancora una volta, il libro non fornisce alcuna verità, ma si limita a mostrarla, puntando il dito in una certa direzione: ed è difficile, quasi impossibile non notare sullo sfondo, nelle famiglie di Foffo e Prato – due famiglie per certi versi antitetiche e pure molto simili – delle strane assonanze. Si stagliano laggiù due specchi rovesciati: due madri assenti, e due padri invece parecchio ingombranti, i cui difetti, nel tempo, vengono assorbiti e poi enormemente amplificati e distorti nelle menti dei figli, desiderosi forse di imitarli senza mai riuscirci, mai, neppure per sbaglio.
Un padre, Valter Foffo, che a pochi giorni dall’omicidio va in televisione da Vespa, e definisce il figlio “un ragazzo modello”, “con un quoziente intellettivo al di sopra della norma”, “forse eccessivamente buono” (eppure era consapevole, a suo dire, del fatto che si drogava da almeno dieci anni, cosa per cui era finito in cura da una psichiatra), un uomo duro, impeccabile, imprenditore tutto d’un pezzo, patron di ristoranti e attività commerciali, la cui principale preoccupazione sembra fin da subito quella della reputazione, ma non tanto per l’omicidio, quanto per il fatto che Manuel “di sicuro non è gay, a lui piacciono le donne”.
Un padre, Ledo Prato, figura di rilievo nella mondo della cultura romana, cattolico di sinistra impegnato su vari fronti, che cura da tempo uno stimato blog e a pochi giorni dall’omicidio non trova di meglio che scrivere una lettera al suo pubblico, una dissertazione forbita e intrisa di retorica dove la figura della vittima – Luca Varani – non esce mai, se non per sbaglio, e in cui il principale obiettivo sembra piuttosto ribadire l’apertura mentale di chi scrive, la sua straordinaria bontà e grandezza d’animo. Lo stesso narcisismo di chi pensa allo smalto per coprire il sangue, come prima la stessa durezza nel reprimere una cosa – l’omosessualità – che niente e nessuno può accostare ai Foffo. Sarebbe prima di tutto un danno per la propria reputazione, così faticosamente costruita in molti anni romani.
Come lettore – non so quale sia l’opinione di Lagioia – credo che qui ci sia la chiave se non per capire, almeno per abbozzare una risposta; che forse nel gesto atroce di Prato e Foffo – solo in parte propiziato dalla cocaina – ci sia un tentativo di confrontarsi con quei padri, con quelle ombre soffocanti, ingoiando i loro difetti e risputandoli fuori, con l’atroce follia dell’abnorme. Qualcosa come due marionette che si mettono davanti a uno specchio, copiano delle pose di qualcuno e poi, trascinati dalla droga, dalla rabbia, dal fatto di essere insieme, si spingono sempre più avanti, al di là dell’immaginabile.
E’ una giornalista del Fatto a dirlo: questi due le ricordano quei filosofi radicali di fine Ottocento, uomini che a furia di abbattere i limiti, forzare i confini, a un tratto si erano trovati di fronte a un vuoto enorme, capace di ingoiarli. E Foffo sognava di uccidere suo padre – non era stato lui a rovinarlo, comprandogli un Maggiolone, quando Manuel sognava una Yaris? – non era stato lui a metterlo all’angolo, costringendolo a studiare Giurisprudenza, ignorando che lui era in realtà uno startupper, destinato a Economia? – mentre Prato lo stimava tantissimo, non voleva altro che compiacerlo. Fra un falso suicidio e una canzone di Dalida, una striscia di coca e un porno, un pompino, sognava di diventare qualcuno, magari operando nella gay culture come suo padre – quell’uomo irraggiungibile – faceva con successo nella cosiddetta “cultura alta”, quella che a Roma si confronta con tombe di Papi e monumenti, quadri e mostre al Vittoriano. Ma ancora una volta non sarebbe bastato, no, non era mai abbastanza…
A morire è stato un ragazzo di ventitré anni, Luca Varani, ma avrebbe potuto essere chiunque, quel giorno: per i due assassini la vittima era soltanto un oggetto, da manipolare a proprio uso e consumo, fino alla sua completa, totale distruzione. Era un mezzo, attraverso cui compiere uno scempio e poi sporcarsi, in un modo che sarebbe stato irrimediabile. Solo così si sarebbe arrivati oltre il limite, facendo qualcosa di memorabile, e dimostrando al mondo – ma anche alle loro famiglie – che se erano dei falliti, beh, sapevano sprofondare in basso con una forza clamorosa, sconosciuta ai più. Avevano contattato diverse persone, in quei giorni, Luca era arrivato quasi per caso.
Eppure lui non era un fantasma, un’idea, e nemmeno una fantasia, era una persona in carne e ossa, che era stato adottato e ora si faceva strada nel mondo, lavorando in una carrozzeria per due soldi, e sempre sperperando tutto, senza alcuna idea né del passato o del futuro, perché la sua vita era qui, era adesso, non apparteneva a nessun altro se non a lui e a Marta Gaia, la sua fidanzata. Per essere felice gli bastava qualche messaggino la notte, prima di addormentarsi, una serata con gli amici o finire abbracciato con lei, sul divano, simile al personaggio di un cartoon; una cena in un cinese sgangherato, un giro al luna park, una passeggiata mano nella mano, per le vie di Roma; e se anche a volte sbagliava, attirato dalla droga, dal gioco d’azzardo, dalle cattive compagnie, quello non era completamente lui, ma un suo doppio, scaturito da un eccesso di vitalità che niente e nessuno poteva spegnere, se non il Male.
Sembra a volte di vederlo, quel ragazzo, di captare la sua presenza, e anche qui sta la bellezza del libro; un’altra scelta per così dire “morale” ed “estetica” al tempo stesso, per cui Lagioia, nel corso della lettura, dà concretezza a quello che avrebbe potuto essere soltanto un nome, a confronto degli assassini; e invece – per tutt’altri motivi – risulta non meno vivo e interessante. Viene da pensare a chi sarebbe diventato, adesso, quale sarebbe stata la sua strada, se fosse sopravvissuto, ma queste sì, sono soltanto fantasie; e purtroppo non ci riguardano più.
Non è facile parlare della letteratura italiana, quella di oggi; da un lato me ne sento coinvolto – dunque meno lucido – dall’altro ho a volte l’impressione di confrontarmi con qualcosa di indefinito, difficile da precisare. Escono ogni anno migliaia di libri, e quasi tutti spariscono in fretta, condannati dal Mercato o dalla loro mediocrità a finire nel dimenticatoio, il che rende difficile indovinare delle assonanze.
Il più delle volte gli scrittori fanno gruppo per ragioni di convenienza, ma difficilmente si uniscono in progetti collettivi, e tantomeno condividono un’estetica. Sono in gran parte delle monadi, piccoli mondi a sé stanti. Le uniche tendenze ben riconoscibili mi sembrano esclusivamente due: una quella dei gialli – siamo invasi da legioni di Commissari, di Investigatori di provincia con tutto un corredo di delitti e dark ladies – l’altra quella della letteratura sentimentale, in un ventaglio di opzioni che va dall’autofiction agli adolescenti inquieti, dalla coppia in crisi – spesso confinata in qualche condominio romano, nel mondo della piccola borghesia – alla denuncia lgbt.
Questo per dire che il libro di Lagioia appare fin da subito come un unicum nel panorama italiano: ci sono state decine di opere ispirati a fatti di cronaca, da Perugia al Circeo, dal Canaro al delitto di Pasolini, ma nessuno, forse, ha mai varcato le soglie del kitsch per diventare qualcosa di più grande (l’eccezione che conferma la regola è il magnifico “Dolci Colline di Sangue”, di Mario Spezi e Douglas Preston).
Se quelli erano instant books, concepiti solo per vendere qualche copia, qui siamo di fronte a un’opera necessaria, che al di là dei suoi pregi e i suoi difetti non poteva non nascere: la sua gravità interna esisteva da prima ancora che il libro venisse scritto, e aveva solo bisogno di venire alla luce, per tutti noi. Lagioia è stato il tramite di questo processo, e chissà se succederà di nuovo, in un prossimo futuro; non posso che augurarglielo perché da lettore mi ha dato un’emozione profonda, quasi indescrivibile a parole.
Da lui non me lo sarei mai aspettato, potevo immaginare qualsiasi altra cosa, scritta da lui, tranne questa, ma ora che ci penso mi rendo conto che era inevitabile: forse solo un provinciale, approdato a Roma per lavoro, e poi rimastovi per quasi vent’anni, poteva cogliere in un solo sguardo tutta l’ampiezza di questa città, la sua Storia macabra e millenaria, luminosa e folle, e la sua immensa estensione di necropoli, che sembra erigere monumenti solo per farsene beffe, e poi inghiottire tutto laggiù, dove ci aspettano gli assassini e i morti e quelli come Foffo e Marco Prato, esploratori del Nulla spintisi avanti, troppo in là per tornare indietro…