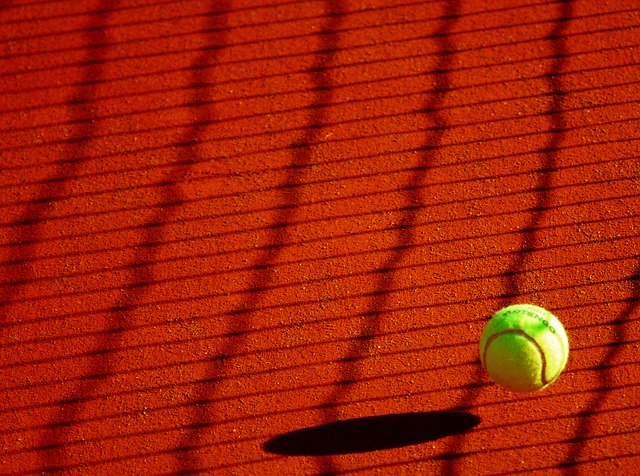Ormai dovrebbe essere questione di un’ora, due al massimo. Tocca all’incontro che precede il mio e i due sono già in campo a scaldarsi… due ragazzini, proprio due ragazzini, ma che giocano decisamente bene. Oggidì imparano presto: impostazione, stile, automatismi. Si muovono disinvolti e sicuri, persino con una sorta di stanca noncuranza. Per certi versi sembrano addirittura annoiati, come se di tennis ne avessero fin sopra i capelli ancor prima di cominciare. Non che ci sarebbe da meravigliarsi se fosse veramente così. In fondo è molto probabile che sui campi da tennis ci siano stati trascinati quando erano piccolissimi, da genitori che sognavano (e probabilmente sognano ancora) grandi successi per i loro adorati pargoli. Il professionismo, i tornei dello slam, la fama e i soldi, Wimbledon… perché no? Guai a non uniformarsi ai modelli ipnotici della televisione: c’è il rischio di sentirsi fuori, out come si dice oggidì.
E allora eccoli lì, coi loro bei completini, i capelli tagliati all’ultima moda, i fisici plasmati da ore ed ore di sfibrante palestra, i figli di mamma e papà che papà e mamma osservano trepidanti da bordo campo, pronti ad insorgere per la prima palla contestata, a prendersela con l’arbitro, a minacciare il mondo intero se le cose dovessero prendere anche vagamente una piega polemica. Loro, i ragazzi non pare che in fondo si interessino molto a quello che stanno facendo. Sembrano più preoccupati che i loro capelli non si scompiglino, che la tutina non si impolveri e che la preziosa racchetta abbia sempre le corde ben allineate che disegnino perfetti angoli retti.
Ogni volta, allorché faccio il tragico errore di mettermi a guardarli, finisco immancabilmente per pensare d’essere nel posto sbagliato. Vero è che, fortunatamente, il mio è un torneo Master, cioè a dire per vecchietti ormai fuori dal giro delle competizioni e, pertanto, non corro per nulla il rischio di dovermi incontrare con questi fichetti classificati e con le loro accordatissime racchette, che usano a due mani, impugnandole come clave, cioè come si gioca oggi che i materiali permettono cose inimmaginabili ai miei tempi. È vero e ne sono lieto visto che la mia età mi colloca ampiamente nella preistoria del tennis, quando la forza contava meno e lo stile era un marchio di fabbrica irrinunciabile anche per chi calcava i campi senza alcuna velleità di passare alla storia, fosse anche quella del circolo che frequentavi.
Pure la mia racchetta, oggi, è in un qualche misterioso ed oscuro materiale che permette forme, dimensioni e, soprattutto, colpi una volta impossibili. Ma la modernità del mio tennis finisce lì e non solo perché il fisico non può più permettersi le libertà d’un tempo. Il fatto è che la mia testa – e non potrebbe essere altrimenti – è rimasta quella di allora, di quando cioè comprai la mia prima racchetta.
Me lo ricordo ancora, quel negozietto scombinato che pareva una merceria e tale probabilmente era. Ma al paese quello c’era. E, infatti, i pochi tennisti locali andavano in città a comprare le loro attrezzature da esibire poi nell’unico campo in terra del paese attorno al quale era nato un modesto circolo di appassionati. A me invece era capitato di passare lì davanti mentre andavo al liceo e di notare in vetrina delle palle da tennis assieme a non ricordo più quali altre cianfrusaglie che però col tennis non avevano nulla a che fare. Ero entrato ed avevo chiesto informazioni. La signora che lo gestiva, m’aveva accolto con un sorriso materno e dopo un po’ c’eravamo accordati sulla marca della mia prima racchetta da tennis. Lei l’avrebbe ordinata ed io potevo pagarla a rate: tutto sulla fiducia. Altri tempi, è ovvio.
Avevo aspettato per quasi un mese, con ansia e trepidazione, l’arrivo di quell’oggetto desiderato. Intanto giocavo con vecchie ‘padelle’ prese a prestito da chi gestiva quell’unico campo in paese, maledicendo l’inadeguatezza di quei malandati attrezzi antidiluviani e convinto che, una volta arrivata la mia racchetta, tutto sarebbe cambiato nel mio gioco.
Dimenticavo di dire che la scelta che avevo fatto era stata dettata unicamente dall’aver un giorno visto, in mano ad un ospite di passaggio al circolo, quella fantastica Neymour. L’avevo desiderata subito, pure se la marca era piuttosto insolita e per nulla conosciuta nell’ambiente locale. Il tizio in questione era un attempato ex professionista e giocava divinamente, almeno per i nostri standard locali e dunque era quasi venuto da sé, per me associare i suoi colpi magici a quell’attrezzo dal nome esotico che manovrava con disgustosa nonchalance.
Nessuno m’aveva detto, allora, che scegliere una marca non bastava ad avere una racchetta come quella che avevo visto. Ero convinto che, in pratica, ogni produttore fabbricasse un solo tipo di racchetta… e questo la dice lunga su quanto ne sapessi di quel mondo. Così ci rimasi piuttosto male quando la racchetta arrivò e scoprii che non somigliava affatto a quella dell’ex campione. La marca era giusta, ma il modello no. Ed era troppo tardi per fare marcia indietro. Già era infatti un lusso quello che m’ero concesso: ridicolo anche solo ipotizzare di comprarne una seconda! E poi, anche volendo, per mettere assieme i soldi, con la misera paghetta che mi passavano in casa, ci avrei impiegato mesi di rinunce alle colazioni di scuola ed al cinema domenicale. Quelli, almeno per me, eran tempi così: in casa c’era quanto bastava per una vita dignitosa, ma niente avanzava per gli sprechi. Ed il tennis, se vogliamo, era proprio uno spreco.
Poco a che fare insomma coi tennisti d’oggi. Però quella racchetta ce l’ho ancora. Il legno del fusto ha ceduto sull’ovale: non ricordo se per banale usura o per un mio gesto di rabbia in campo. O magari durante uno dei tanti traslochi. Dopo di lei, di racchette ce ne son state tantissime e tutte son state o regalate, o buttate via per far posto a fiammanti nuove arrivate. Solo lei, quella gloriosa Neymur è rimasta in casa. Prima ficcata in qualche valigia o scatola, infine assurta alla gloria di essere appesa ad un comunissimo chiodo sulla parete, dopo aver tolto le corde ormai sbriciolate.
In cielo stanno arrivando delle nuvole. Dopo aver tanto aspettato stai a vedere che nemmeno riesco a fare la mia partita! Intanto sul campo i due annoiatissimi ragazzi continuano a scambiarsi colpi… magari sarebbero contenti se cominciasse a cadere qualche bel gocciolone. Così se ne possono andare prima che il loro disgusto li costringa a dare di stomaco a bordo campo. Ma che diavolo vado dicendo? D’accordo che mi stia passando la voglia di giocare. E ci sta pure che senta una maledetta nostalgia di quella vecchia Neymur che quasi correrei a casa a prenderla giusto per godermi la faccia costernata del mio avversario quando scendessi in campo con quel malridotto arnese. «Dov’è la candid camera?» chiederebbe al giudice di sedia se solo fosse persona di spirito. Invece, questo lo so già perché me l’hanno presentato arrivando al circolo, per quanto mio coetaneo m’ha dato l’impressione d’appartenere anche lui alla schiera dei fichetti annoiati. Così al massimo esibirebbe un sorriso di circostanza che non basterebbe certo a nascondere quello che pensa. Che cioè sono un po’ tocco.
Ma come dargli torto? E perché diamine continuo ad iscrivermi a questi tornei quando ormai sto per arrivare ai cinquant’anni? Almeno potessi ancora esibire la mia fiammante Neymur, forse un senso ci sarebbe ancora, se non altro per ricordare al mondo che ci son stati altri tempi e che la modernità, delle volte, corre troppo veloce per un’anima che continua a viaggiare con la lentezza di queste nuvole. Che intanto però, il cielo l’han ricoperto tutto e, nel giro d’un niente, l’acqua vien giù che dio la manda.
Si capisce presto che di giocare, per oggi, non se ne parla più. Vedo facce più buie delle nuvole che continuano a scaricare secchiate, ora alternate a tuoni e lampi. Invece la mia, di faccia, è distesa e rilassata. Metto là anche io qualche stupida frase di circostanza, ma dentro giubilo come se m’avessero appena servito uno spumeggiante bicchiere della mia vedova preferita: la Veuve Clicquot Ponsardin. Infilo rapido gli spogliatoi ma nemmeno mi cambio: ficco in borsa i vestiti “civili” e le scarpe di cuoio, raccolgo il borsello e tiro fuori l’ombrello. Stringo poi qualche mano; prometto, mentendo, che il giorno successivo non sarei mancato d’essere lì per il mio turno, apro l’ombrello e vado a recuperare la mia auto. A casa m’aspetta la mia fida e scassata Neymur, una gatta sorniona acciambellata sul divano ed una vedova di lusso in frigo.
Pino Chisari, 2016