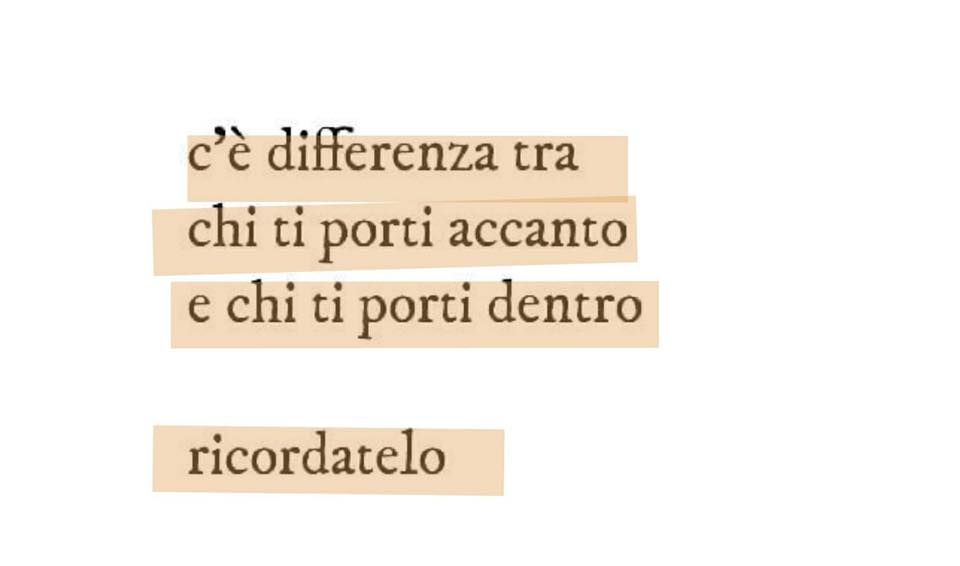Prima parte.
Sdraiato sul letto della casa di cure dove era ricoverato da alcuni giorni, Giuseppe, teneva gli occhi chiusi; non dormiva, stava morendo, lentamente e inesorabilmente.
A ogni ricovero, dopo le terapie, qualche trasfusione gli regalava un’energia temporanea, ma era dimagrito e rughe profonde solcavano il viso stanco e sofferente che appariva di un colore cinereo.
Gli avevamo diagnosticato un tumore alle ossa un anno prima e negli ultimi mesi era peggiorato; a dire del suo medico, non gli rimaneva molto tempo da vivere.
All’inizio aveva sperato in un errore ma, alla fine, si era rassegnato alla crudele realtà.
Non si era mai sposato, figlio unico, aveva perso i genitori anni prima e si ritrovava solo, a quasi settant’anni, senza parenti e amici.
A dire il vero, fino a un anno fa, c’era Giulio, con il quale giocava a carte quasi ogni pomeriggio al circolo ricreativo di cui erano entrambi soci.
Durante la bella stagione facevano lunghe passeggiate in campagna, ricordando i vecchi tempi, cercando di dare un significato all’ultima parte della loro vita.
Invidiava Giulio, il quale aveva una bella famiglia ed era sempre indaffarato.
Le sue giornate erano rallegrate dalla moglie Luciana e da tre figli con altrettanti nipoti. Nonostante avesse giornate piene, Giulio, trovava sempre il tempo per stare con lui.
Era consapevole di avere un brutto carattere che lo aveva portato all’isolamento e gli aveva creato problemi anche nelle relazioni con i colleghi di lavoro; era cocciuto di natura e aveva spesso modi sgarbati.
Gli amici di bevute o di carte, li frequentava soltanto al circolo mentre con Giulio, che era suo amico dai tempi del liceo e gli voleva bene nonostante i suoi difetti, c’era un rapporto unico e profondo, merito del carattere allegro e paziente di quest’ultimo.
«Can che abbaia non morde», gli ripeteva sempre sorridendo dopo qualche accesa discussione.
L’ultima volta però, aveva esagerato, ne era consapevole.
Lo aveva offeso e ferito, lo aveva trattato male e non gli aveva chiesto scusa preso, come sempre, dal suo orgoglio smisurato e dalla sua stupida presunzione.
Giulio, che era un buono di natura, dopo alcune settimane lo aveva cercato, ma Giuseppe non aveva voluto ammettere di avere torto.
Non si vedevano da quando avevano bisticciato, cioè da quando si era sentito male e gli avevamo diagnosticato il brutto male.
«Non so che farmene della tua amicizia» erano state le sue ultime parole.
Forse, in quel momento difficile, la sua reazione era stata come una forma di difesa, aveva ricevuto la notizia del male incurabile e non sopportava la pietà di nessuno, tantomeno quella del suo unico amico.
Cercava solo la solitudine e si sentiva braccato, come un animale ferito, impegnato a commiserarsi aspettando la fine.
Era sicuro che Giulio, buono com’era, avesse già dimenticato il torto e che se avesse messo da parte il suo stupido orgoglio e lo avesse cercato, lo avrebbe perdonato e ora gli sarebbe stato vicino per aiutarlo e fargli compagnia.
Era stato tentato più volte di chiamarlo al telefono, di chiedergli scusa, ma, non ne era stato capace.
Pensò: «Sono anche un grande egoista».
In quel periodo, dedicato a esami, ricoveri intermittenti nella clinica privata e le terapie, i ricordi si accampavano nella sua mente in un assedio tenace e persistente senza dargli pace.
Aprì gli occhi, mosse piano il braccio sinistro al quale era attaccata una sacca di plasma, e guardò fuori dalla finestra, attraverso le tende bianche.
Il cielo era cupo, un vento arrabbiato spingeva verso ovest un gregge di nuvole scure cariche di pioggia.
La burrasca in arrivo andava a turbare l’inizio mite della primavera ed egli pensò:
«Come quella sera …».
Bussarono alla porta della stanza e, senza attendere risposta, spuntò il viso sorridente di don Luigi:
«Come sta il mio paziente brontolone?» chiese il sacerdote entrando senza aspettare risposta.
«Come il solito», rispose Giuseppe brusco desiderando che non fosse venuto.
Don Luigi non si lasciava certo scoraggiare dai suoi modi, ignorava la sua avversione e gli chiedeva ogni giorno se avesse bisogno di qualcosa; lasciava affianco al letto qualche rivista, o quotidiano e gli rivolgeva parole di conforto.
Gli aveva chiesto più volte se avesse qualcosa da confidargli, qualcuno da chiamare, e alla domanda:
«Vuoi confessarti?» Giuseppe scuoteva vigorosamente la testa brizzolata.
Nonostante non lo incoraggiasse minimamente, il prete, tornava ogni giorno e gli raccontava spesso aneddoti curiosi e divertenti della sua vita di sacerdote, dei suoi parrocchiani, della sua vecchia mamma che, ormai vedova, abitava con lui e lo accudiva come fosse ancora un bambino.
Il prete, sui cinquant’anni, alto e magro, con folti capelli castani ricamati da qualche filo argenteo, disse:
«Posso sedermi?» mentre accostava al letto una delle due sedie.
«Se ti dicessi di no cosa faresti?»
«Sei più cocciuto di me.»
«Forse sì, ma non posso pensare che tu viva così arrabbiato con tutti, che non accetti una parola di conforto, che non apri il tuo cuore a nessuno».
Proseguì fissandolo:
«Tutti abbiamo bisogno di confidarci, qualcuno cui chiedere perdono …».
Non rispose ma lo guardò a lungo fingendo indifferenza, quasi con sfida.
Sembrava gli leggesse nei pensieri, che conoscesse il suo segreto, il tormento che, ormai, non gli dava tregua.
«Domani me ne torno a casa», disse per cambiare discorso.
«Sono contento per te, ti lascio qui il mio numero di cellulare nel caso avessi bisogno di me», aggiunse il prete con un sorriso.
«Io non ho più bisogno di niente e di nessuno», rispose cocciutamente Giuseppe e chiuse gli occhi fingendo di dormire per mandarlo via.
Don Luigi comprese, lo salutò stringendogli la mano bianca e fragile come quella di un bambino, che l’uomo teneva abbandonata e inerte sul lenzuolo candido, e uscì con passo leggero.
Giuseppe riaprì gli occhi e pensò:
«Forse ha ragione lui, anche se non ho mai creduto in una vita dopo la morte, in questo Dio che non mi sembra né buono né misericordioso come dicono, prima di lasciare questa vita, dovrei in qualche modo riparare a una parte del male che ho fatto; anche se piccola, sarà meglio di niente; devo fare pace con Giulio e sistemare l’altra faccenda».
Rimorsi di Matilde Falco – Parte prima