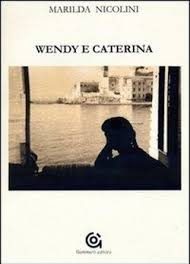IN PUNTA DI PIEDI
Brigida era entrata in punta di piedi nella camera di Concetto Scalavino, per chiudere le tende che il sole, nonostante volgesse all’imbrunire, ancora smerigliava di rosso le pareti, prendere ordini per la cena e sincerarsi delle sue condizioni, che quel giorno, contrariamente al solito, la campanella di servizio aveva suonato solo una volta perché venisse fornito di pennino e carta da lettere. I fogli, malamente scarabocchiati, erano scivolati a terra quando lui s’era addormentato. Scrivere in quella posizione scomoda non era facile, così come il trascorrere intere giornate immobilizzato a letto.
Quanto doveva pesare ad un uomo d’azione come lui quella forzatura e la conseguente dipendenza da lei, per le veci nella casa, e da Giovanni Basile per quelle negli affari!
Ma se poteva fidarsi di loro per le pratiche quotidiane così non era per quelle più intime, e a causa dell’incidente, sospese e d’improvviso incerte, e che pure dovevano tremendamente angosciarlo non potendo, per queste, affidarsi ad alcun vice.
Brigida aveva raccolto i fogli, tirato le tende, e senza far rumore era uscita dalla stanza.
Nell’ingresso aveva intercettato Rebecca e ponendole le lettere in mano, aveva detto: «Sono certa che avete una grafia migliore di quella di vostro padre. Ricopiatele e, se occorre, correggetele.»
«Cosa sono?» Aveva chiesto sorpresa la ragazza sbirciando i fogli fittamente coperti da una scrittura maschile puntuta e irregolare, a tratti illeggibile.
«Lettere d’affari: il vostro possibile passaporto per l’indipendenza.» Le aveva risposto Brigida seria.
«Davvero siete convinta che copiare in bella grafia queste lettere di mio padre, per di più trafugate dalla sua camera, mi varrà un suo encomio? »
« Avete ragione, sarà molto arrabbiato con voi, ma anche colpito sbalordito dall’intraprendenza del gesto e dall’audacia di aver osato entrare in un contesto che sicuramente lui giudica non alla vostra portata. Sono altrettanto certa, però, che voi saprete tenergli testa.» Aveva ribadito sicura la governante.
Rebecca l’aveva guardata perplessa: «Non riesco a seguirvi: perché mio padre dovrebbe trovare significativo questo mio gesto? Si vede che non lo conoscete e avete avuto poco a che fare con lui. E’ un despota che vorrebbe tutti piegati alla sua volontà, e dove non arriva col convincimento usa la coercizione, tanto che …»
«Ma è anche un uomo terribilmente solo.» L’aveva interrotta Brigida. «Lo attestano quelle sue lettere faticosamente scritte a causa della posizione precaria a cui l’immobilità lo costringe, e per questo illeggibili. Poteva chiedere aiuto a me, a voi o a Gemma, ma non l’ha fatto. Per stupido orgoglio, direte voi, ma anche perché crede di non avere nessuno di cui potersi fidare. La morte di Mimì Messinese ha reso evidente questa mancanza accentuando la sua solitudine.»
«C’è quel Giovanni Basile, il suo braccio destro. Di lui dovrebbe fidarsi.» Aveva obiettato seccamente Rebecca
«Confondete la fiducia con l’intimità. Sono cose diverse. Rifletteteci.» Brigida aveva detto lasciandole nelle mani il pacchetto delle lettere, per sparire poi nella cucina.
…e con quelle aveva fatto il suo ingresso nella camera che divideva con Gemma.
Assorta nei propri pensieri, Rebecca, non s’era accorta della presenza della sorella rimasta in silenzio ad osservarla selezionare e disporre in bell’ordine i fogli sullo scrittoio.
Solo dopo, alzando gli occhi, l’aveva vista, e davanti a quello sguardo provocatoriamente irridente per la prima volta in vita sua, s’era sentita a disagio, come colta in fallo.
Una sensazione nuova e difficile da decifrare per lei, cucciolo di lupo, avvezza ad espletare ogni cosa limpidamente alla luce del sole, in piena autonomia, libera da qualsiasi pregiudizio e inganno.
Chiaramente, però, aveva percepito che la recente, sottile trama, su cui s’andava imbastendo il legame nuovo e inesplorato con Gemma, rischiava, alla luce dei recenti malintesi, di lacerarsi, perché sebbene entrambe perseguissero lo stesso progetto i contrasti erano ora sul metodo per realizzarlo.
Non era, per nessuna delle due, questione di orgoglio ma era mancato loro l’imprinting alla condivisione, per cui erano cresciute insieme sotto lo stesso tetto ma distanti ed estranee l’una all’altra.
L’unico vero sentimento che le legava era quello del rispetto piuttosto che dell’affetto.
Se non c’era stata fino a quel momento tra loro complicità tanto meno c’erano state discordie o baruffe, l’una rispettosa della presenza dell’altra, vissuta naturalmente senza l’ingombro di quei sentimenti forzati in nome della comune matrice di nascita.
Ma ora che gli schemi s’erano rotti, e il mondo esterno, con le sue orribili distonie aveva invaso i loro perimetri esistenziali, tracimando col pesante carico delle contraddizioni, delle incoerenze e dei sofismi psicologici, la fragile impalcatura su cui basava la loro intesa iniziale, rischiava di non reggerne l’urto.
«Ora svolgi per lui mansioni di segretaria? » Aveva domandato ironica Gemma. Poi, senza darle il tempo di rispondere aveva aggiunto: «Tu e la signora Catalano parlavate nell’ingresso così, mio malgrado, ho ascoltato la vostra conversazione.» Quella puntualizzazione avrebbe potuto avere apparenza di scuse, ma il tono sarcastico, e il sorriso canzonatorio, chiaramente smentivano essere tale.
«Mi ha chiesto di riscrivere in grafia leggibile queste lettere di papà. Tutto qui.» Rebecca non aveva raccolto la provocazione consapevole che nessuna spiegazione, per quanto improntata al buonsenso, l’avrebbe convinta.
«Farai qualsiasi cosa lei ti chiederà?» La domanda suonava come uno sberleffo.
«No. Solo quello che riterrò opportuno.» Aveva risposto Rebecca guardandola negli occhi.
«Come immaginavo: hai già dimenticato tutto, mentre io, invece, non dimentico niente.» C’era delusione nella voce di Gemma. Ma anche una sfida.
PUNTI DI VISTA ESTERNI E DISCORDANTI
«Non ho dimenticato neppure io, ma ora la situazione è cambiata. Mimì Messinese è morto e con lui anche il progetto di nostro padre, ma nonostante il suo riprovevole agire, trovo ingiusto che Giandomenico e la sua famiglia lo reputino colpevole della sua morte: non lo ha ucciso lui, Mimì.» Aveva ribadito con forza Rebecca.
«Ne sei davvero convinta? Sbagli a difenderlo, perché lui ha ucciso anche la mamma.» In quella sentenza inappellabile, la voce di Gemma era risuonata gelida, in contrasto, però, con lo sguardo compassionevole rivolto alla sorella prima di uscire dalla stanza.
Rebecca, rimasta sola, aveva gettato un’occhiata pensosa ai fogli sparsi sullo scrittoio chiedendosi se quella silenziosa collaborazione, per altro non richiesta da suo padre, ma caldeggiata dalla signora Catalano, non fosse una trappola.
Abituata a far riferimento solo a sé stessa e al suo istinto, si trovava ora a doversi districare in un coacervo d’ipotesi, di verità vere o presunte, di punti di vista esterni e discordanti eppure tutti allo stesso tempo plausibili.
Aveva ragione Gemma nell’affermare che il loro padre avesse ucciso la mamma, seppure lei era ancora viva e, al di là dello smarrimento mentale, godeva di una salute di ferro, ma continuava a credere, però, che non fosse responsabile della morte di Mimì Messinese, seppure lui fosse realmente morto, stroncato da un infarto provocato dall’ansia, dalle pressioni e dalla sua incapacità a barcamenarsi in una situazione dove non aveva visto via d’uscita, ma che lui stesso aveva contribuito a creare.
In base a questo ragionamento, allora, erano colpevoli anche lei e Giandomenico, che pur non accettando quella situazione, per motivi diversi l’avevano comunque tollerata. E protratta.
E se così fosse, qual’era il grado individuale di colpevolezza?
Perché un’intelligenza sensibile come quella di Giandomenico non aveva vagliato questo punto di vista?
O forse lo aveva fatto, e se ne era ritratto inorridito.