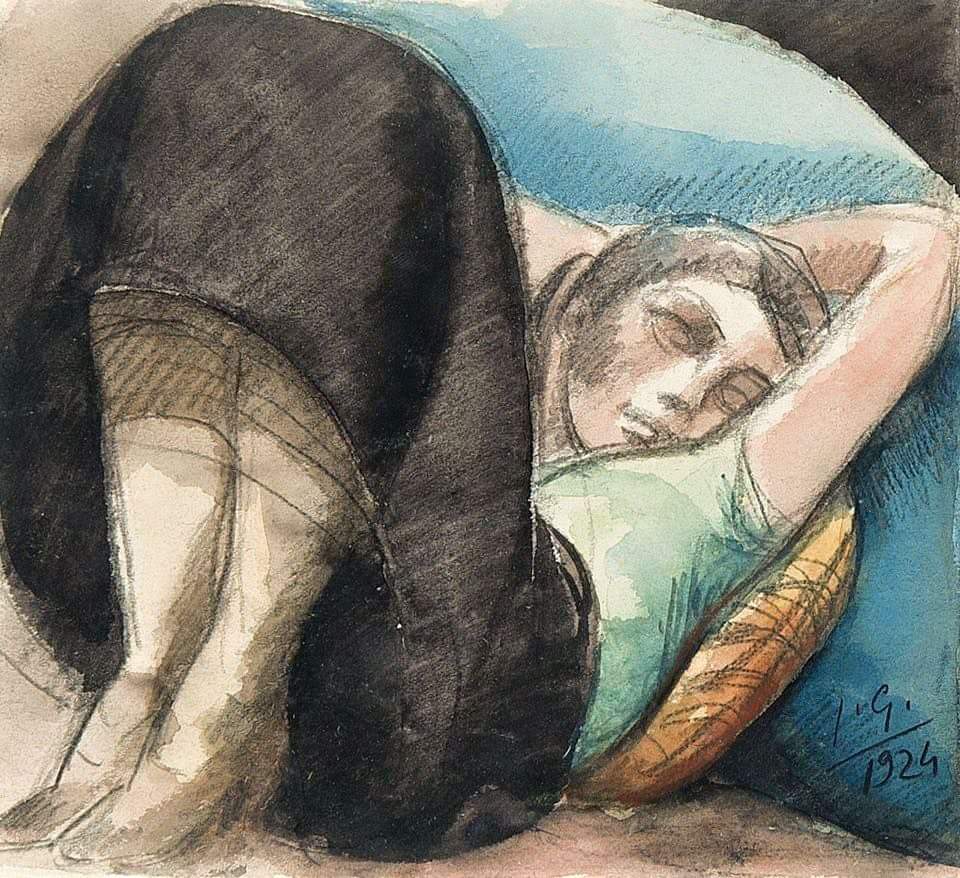Con Roberto ci eravamo persi ai tempi dell’Università, anzi, verso la metà, quando io ho cominciato a lavorare e improvvisamente le priorità della contestazione mi sono sembrate meno importanti.
«Eddai, Francesco» mi diceva «fai uno sforzo e vieni anche tu, è importante!».
Io magari avevo fatto il turno di notte e dovevo rimontare alla sera, e proprio non avevo voglia di giocare a rincorrermi con i celerini.
«Sono stanco, Roberto, vado a stendermi un paio d’ore…».
«Ma solo per questa volta, cosa ti costa?».
Allora finivo per incazzarmi e litigavamo:
«Ma vaffanculo! Hai mai lavorato in vita tua? Mi sono rotto i coglioni dei vostri giochini di merda, tu e quelli di Lotta Continua!».
«E che Lotta Continua? Io sono con Potere Operaio, non ho più niente da fare con quella gente lì, figli di papà!».
«Da quando?».
Lui ci pensa un attimo.
«Ma saranno almeno tre settimane».
Ci siamo rivisti nei giorni del G8. Io allora lavoravo per un servizio di ordine pubblico e stavo ritornando a casa in moto dopo un turno di dodici ore, quando sono capitato in una delle zone dove si raccoglievano i manifestanti, sotto gli sguardi dei poliziotti nascosti dalle visiere dei caschi. Incuriosito, mi sono fermato ad osservare, badando bene a non mettermi in mezzo e a tenermi una possibile via libera, quando ho visto una sagoma che mi sembrava di riconoscere. Era un fotoreporter con una casacca gialla sopra la maglietta nonostante il gran caldo, e anche lui sembrava aspettare che succedesse qualcosa. Mi sono tolto il casco e l’ho osservato meglio: non c’erano dubbi, era proprio lui!
«Roberto!» ho gridato, sventolando una mano.
Lui si è voltato, ha esitato cercando di capire da dove venisse la voce, poi mi ha visto.
«Francesco!».
Io ero fermo sulla mia moto accostata sulla destra, così è stato lui ad attraversare la strada per raggiungermi.
«Cosa ci fai qui?» mi ha chiesto, dandomi una pacca sulla spalla.
«Cosa ci fai tu?» ho risposto «io ci abito».
Ha riso.
«Già, già. Io invece sono andato a vivere a MIlano. Bella merda» ha aggiunto, vedendo al mia espressione.
«Stavo per dirlo! Lavori per la stampa, adesso?».
«Io? Neanche per idea, lavoro in Pirelli».
«E allora cosa ci fai travestito da reporter?» dico, indicando il tesserino plastificato che porta al collo.
Lui lo prende in mano, ride e mi fa l’occhiolino.
«Io sono qui per documentare» dice «e possibilmente non prendere delle botte. Ricordi i bei tempi?».
«Non è che fossero tanto belli» obietto, scettico.
«Ma dai che ci siamo divertiti! Il tesserino fa parte della scena».
«Farlocco?».
«Ovviamente, ma ho più paura di una manganellata in testa che di una denuncia per falso!».
Rido anche io.
«Sempre uguale!» esclamo.
Dopo quello scambio di convenevoli ci guardiamo entrambi intorno. So che pensiamo la stessa cosa: siamo in una piazza in cima ad una via in ripida discesa, rettilinea, che sarà lunga cinquecento metri. Proprio a metà di quella strada noi andavamo a scuola, al liceo, e la prima cosa che abbiamo imparato era di non partire mai da lì con una manifestazione, perché sei i celerini ci caricavano in discesa era un massacro. Nossignori: raduno in fondo alla via e poi in centro, dove c’erano cento vie di fuga. Invece quei ragazzi che sventolavano enormi mani bianche si erano piazzati proprio in cima e stavano per cominciare a imboccare la strada in discesa, con la polizia sopra di loro.
«Si faranno ammazzare» osservo.
«Già» fa lui «sono degli idioti.
«Sono di fuori, non conoscono la città».
«Allora sono idioti due volte, anzi tre».
«Tre?».
«La prima per non essere venuti nelle settimane precedenti la manifestazione a fare dei sopralluoghi» mi dice, enumerando sulle dita della mano, come faceva sempre, «la seconda per essersi messi in questo casino con quelle cazzo di mani bianche».
«E la terza?».
«La terza per essere venuti a cacciarsi in questa trappola: basta una scintilla perché quei bastardi si scatenino».
Guardo i poliziotti dietro gli scudi.
«Se fossi vestito in quel modo con questo caldo sarei incazzato come una bestia anch’io».
«Già».
La manifestazione, poche centinaia di persone, è già stata ingoiata dalla strada. I celerini la seguono.
«Dici che li caricano?» chiedo.
«Dieci contro uno, dopo la metà della strada».
Scuoto la testa, la piazzetta ormai si è svuotata.
«Andiamo a bere qualcosa?» mi chiede Roberto, indicando il bar che sta rialzando prudentemente la seracinesca.
«E le tue foto?».
«Da qui alla fine ne avrò da fare!» mi risponde, così ci avviamo, raggiungiamo uno dei tavolini che sono appena stati riaperti e ci sediamo, sotto lo sguardo invidioso di un sottoufficiale della Celere.
Siamo stati facili profeti: non è passato un quarto d’ora da quando ci siamo seduti che si odono dei colpi soffocati, le sirene cominciano a ululare e si vede dell’agitazione in cima alla strada.
Io e Roberto, istintivamente, ci mettiamo a guardare le foglie degli alberi, poi scoppiamo a ridere.
«Le vecchie abitudini sono dure a morire, eh?» esclama lui.
«Perché, a te piace respirare i lacrimogeni?».
I rami restano immobili, gli scontri sono qualche centinaio di metri più in basso, il gas è più pesante dell’aria e sarebbe sceso a valle, possiamo stare tranquilli.
«Però almeno tu potevi partecipare» mi istiga lui, sorseggiando la sua bibita gelata attraverso la cannuccia.
Sorrido.
«No, grazie, ho esaurito la mia dose di imbecillità durante la giovinezza».
«Perché, combattere contro la globalizzazione è da imbecilli?».
Lo guardo dritto negli occhi per vedere se dicesul serio o mi sta sfottendo. Mi sfotte, ovvio, come sempre. Mi schiaccia l’occhio.
«Confessa che stavi per mandarmi a fare in culo» dice.
«Avrei potuto anche darti un pugno in faccia» ribatto, irritato.
Lui alza le spalle.
«Cosa è rimasto di quegli anni, Francesco?».
Sospiro, cercando una buona risposta.
«Non lo so. Esperienza. Disillusione. Niente».
«Già: niente. È la vita».
Bevo un sorso dal bicchiere. La bibita fredda mi giunge di colpo nello stomaco, provocandomi una fitta. Faccio una smorfia di dolore.
«Sai cosa ho pensato l’altro giorno?» gli dico, mentre lui mi guarda incuriosito.
Indico il sole:
«Mi è venuto da riflettere che quella palla nel cielo ha una massa e delle dimensioni talmente grandi che è persino difficile concepirle, e noi che viviamo su questa terra come formiche su una noce di cocco siamo trascinati a girare intorno ad esso da forze a noi incomprensibili, che sappiamo appena descrivere…»
«Ti sei dato al misticismo?».
Non faccio caso alla provocazione e continuo:
«È tutto talmente grande, e noi siamo così piccoli, così insignificanti! Che senso hanno le nostre vite, le grandi ideologie, le religioni, di fronte a tutto questo, che poi è solo un granello di sabbia nel grande mare dell’universo? Le cosmogonie costruite con le figurine dei personaggi dei libri sacri?».
Roberto si rende conto che sto parlando seriamente e cerca di venirmi dietro.
«Sì, ma anche se pensi a tutto questo, cosa cambia?».
«Non lo so. Forse che sarebbe meglio smetterla di rincorrere i sogni o rimpiangere il passato e vivere con quello che abbiamo?».
Adesso anche lui è pensieroso.
«E cosa abbiamo?» mi dice «cosa ci resta se abbandoniamo le nostre speranze e i nostri ricordi?».
I rumori dalla strada si fanno più forti. Sentiamo delle grida arrivare fino a noi.
«Tu mi chiedi qual’è il senso della vita» rispondo «e io non lo so. Dico solo che credo sia inutile cercarlo, perché tra qualche anno moriremo, come tutti, e non l’avremo comunque trovato».
Restiamo qualche istante in silenzio, a meditare su quello che ci siamo detti, poi vediamo un ragazzo che arriva in cima alla strada. È stravolto, si guarda a destra e a sinistra, poi corre dalla nostra parte, sfiora il tavolino e continua a scappare lungo il viale alberato. Pochi istanti dopo arrivano i tre celerini che lo stavano inseguendo, cercano di vedere dove è finito, poi ci notano. Noi sosteniamo il loro sguardo. Uno di loro si leva il casco, sotto è sudato marcio. Intuiamo che vorrebbe venire a bere, ma un collega lo prende per la manica e lo riporta giù.
«Lavoro di merda» osserva Roberto.
«C’è di peggio».
«Sì, ma comunque è un lavoro di merda» dice, alzandosi. «Ti saluto, France, è stato bello rivederci».
«Sì, ogni tanto dovremmo sentirci».
«Hai ragione» fa, e con la sua macchina in spalla ritorna a seguire la manifestazione.
Io resto seduto, in attesa che il cameriere mi porti il conto, e intanto lo vedo allontanarsi.
Non ci siamo neanche scambiati i numeri di cellulare.