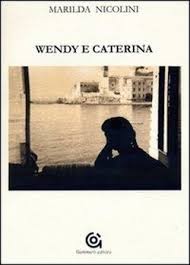Kalifa non raccontò mai della sua vita in Niger, e neppure di essere stata allieva del Dottore, l’unico personaggio illustre, anche se caduto in disgrazia, a cui l’Isola aveva dato i natali.
Si sarebbe servita, invece, con parsimonia e discrezione, della sua conoscenza dei segreti dell’Isola che Il Dottore le aveva rivelato e sui quali avrebbe costruito la sua fama d’indovina e consolidato la sua leggenda, supportata da un empatia naturale, una intelligenza sensibile, ed un intuito istintivo davvero notevole.
E la sua fervida fantasia avrebbe fatto il resto.
Si stabilì in una casupola abbandonata, su un’altura dell’Isola, al riparo dai micidiali marosi e dalla valanga delle cose, vive o morte, che scagliavano a riva.
Negli anni avrebbe trasformato quella casetta dimessa, abitata dai ragni, dalle lucertole e da qualche topo naufrago, in un fantastico monumento surreale, una cattedrale pagana che sarebbe assurta, nel tempo, come meta per turisti, studenti d’architettura e ingegneria, artisti in cerca d’ispirazione, e tutte le anime inquiete che tra quelle mura ritrovavano la pace.
Ma, allora, era solo una casetta ad un piano, dalle mura lebbrose e le persiane divelte, munita sul retro di un giardinetto in rovina invaso dall’erba gramigna e da colonie aggressive di formiche predatrici.
Kalifa avrebbe dovuto ricostruire dalle fondamenta, un pezzetto per volta, accingendosi nell’opera ciclopica di un insetto che aspiri a tirar su una torre partendo da una pietruzza, e per compiere tale impresa si sarebbe imposta lo stesso rigore col quale le suore l’avevano allevata.
Le suore della Missione erano rigorose ma non dispotiche: dispensavano il corpo di Dio in maniera pratica, attraverso i pasti, coscienti che per nutrire l’anima bisognava prima saziare il corpo.
Insegnavano come un gioco il segno della croce, invece dei salmi cantavano filastrocche e raccontavano, sotto forma di fiaba, le vite dei Santi, rielaborate con spirito materno, epurate dal fanatismo religioso e dall’orrore conseguente del martirio, perché nelle terre d’Africa di martiri ce ne erano a migliaia ogni giorno, uccisi dalle carestie e dalla siccità, massacrati dalle malattie e dalle guerre.
Le missionarie sapevano che molti dei loro piccoli ospiti, bambini abbandonati e orfani, erano solo dei sopravvissuti temporanei, testimoni indifesi della brutalità dell’uomo e alla mercé di una natura prodiga ed avara al tempo stesso.
Da quelle parti si moriva giovani e senza neppure aver avuto il tempo di peccare.
Kalifa, sotto la guida del Dottore, espletava alle funzioni infermieristiche nel piccolo ospedale della Missione, ed era, tra le sue allieve, la più brava: mano sicura e cuore indomito, non si lasciava spaventare dal sangue e dagli orrori inflitti alla carne, interveniva con prontezza supplendo, con intuito brillante, alla carenza di formazione specifica, seguendo alla lettera il primo insegnamento del suo maestro: «Non mostrare mai la tua paura né la tua inadeguatezza, devi essere rassicurante e professionale anche nei momenti dell’impotenza, agire sulla base delle tue conoscenze e, se queste non bastano, sul tuo istinto e sul buon senso, solo così avrai pienamente adempiuto al tuo compito.»
La Missione era un microcosmo abitato per lo più da donne e bambini, con la presenza stabile del Dottore e di due factotum indigeni che si occupavano dei lavori più pesanti, assolvendo anche alla funzione di guida. Durante il giorno la Missione espletava infaticabilmente i compiti di assistenza spirituale e materiale al servizio di chi vi ricorreva, con la cucina e l’ospedale che entravano in funzione già alle prime luci dell’alba.
Un piccolo pozzo miracoloso che attingeva direttamente dal fiume Niger, ed un paio di vasconi per la raccolta delle acque piovane, consentivano alle suore di gestire un campicello coltivato a mais e patate, e poter rifornire gli indigeni che percorrevano tragitti assurdi per raggiungere la Missione per riempire d’acqua i pesanti orci di terracotta che le donne trasportavano sul capo, ed i giovani in grandi secchi in bilico sulle spalle, attenti a non disperderne neppure una goccia, consapevoli della responsabilità di quel prezioso carico che le suore definivano “l’oro della terra”