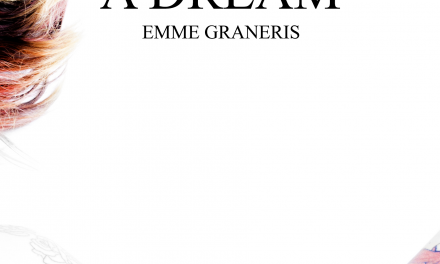Il Nero affumicò un altro lembo di carta stagnola, respirò una lunga boccata di fumo bianco e guardò al di fuori della finestra. La città era una superficie congelata, un riflesso mutevole che si estendeva per chilometri, che ghermiva il panorama, soffocandolo.
Nell’ombra dei palazzoni il fiume scorreva silenzioso, frequentato dai tossici e sporcato dei fiori bianchi delle loro siringe.
Anche se erano lontani, il fiume lo obbligava a ricordare il campo del Selvaggio, la roulotte di suo padre, la sua cinghia.
Forse non era mai stata la scelta più saggia quella di andarsene, ma era sicuro che in quel momento fosse la scelta migliore.
Lui e Rio non erano come loro, dopotutto, loro erano una coppia di pirati che solcava il fiume della discarica, erano piccoli sognatori che sarebbero diventati grandi uomini liberi, marinai di ventura in un mondo da esplorare. Questo e nient’altro.
Il Nero sistemò un’altra striscia di crack sul lucido della carta, aveva bisogno di lenire il dolore, di calmare il male con altro male, di mettere a tacere i sensi di colpa.
Forse aveva ragione Simona, era troppo presto per scappare, o forse erano scappati prima che il campo consumasse loro, prima che li rendesse come “loro”.
Il Nero trattene quei pensieri e li soffiò nel fumo bianco, lasciandoli a galleggiare tra l’aria e la luce qualche secondo, prima di finire divorati nel vuoto.
Forse era tutto giusto, forse erano capitati esattamente dove dovevano capitare, in un confluire di forze ed energie karmiche che l’avevano codotto a Simona, al suo letto.
Cosa c’era, in lei, che in nessun’altra parte del mondo avrebbe mai trovato? Perché l’aveva sentita così importante e vicina?
Forse erano tutte quelle overdose di tristezza, il crescere con il peso di quell’anima invisibile che le aveva sentito dentro. O magari era altro, qualcosa così profondo che neppure facendoci l’amore era riuscito a trovare.
Il passato lascia dentro una scia, come la schiuma in coda alle navi, una scia di luce e di ombre che è sempre pronta a balzarti addosso ogniqualvolta chiudi gli occhi o rallenti. Chissà che scia nascondevano gli occhi dolci di quel mattino, chissà quale passato fratturato e scomposto la obbligava a soffrire così tanto.
La fiutava come un lupo ne fiuta un altro, alla stessa maniera dei tristi predatori nelle loro selve ghiacciate, e sapeva che anche lei, in qualche maniera, aveva fatto lo stesso, che anche lei sapeva, che anche lei dubitava e che anche lei, prima o poi, gli avrebbe domandato il conto del suo passato.
– Perché non mi parli mai del tuo passato? – gli avrebbe domandato.
– Perché è un baratro nero – le avrebbe risposto.
– Cosa vuol dire?
Lui avrebbe guardato in basso, come se in un punto, poco distante dall’ombra del suo naso, si fossero generate delle immagini, poi i mondi e le storie della sua esistenza.
– Voglio dire che è un baratro nero – avrebbe risposto, – e non voglio che tu ci cada dentro.
Avrebbe voluto portarla fuori, un giorno, in una giornata pulita, senza carta stagnola a confondere i pensieri, magari con il sole e l’aria tiepida, quel genere di giornate così verdi e serene che puoi vivere solo da bambino.
Avrebbero parlato, avrebbero passeggiato sui marciapiedi di ogni strada, all’ombra di ogni palazzo e di ogni viale, doppiando anziani e deridendo le coppiette.
Si sarebbero fermati a riprendere fiato parti dello zoo, magari guardando i pesci rossi nuotare sul fondo della sua fontana.
– Ci sarò passato mille volte – avrebbe detto lui, guardando l’ingresso. – E non ci ho mai messo piede.
Lo zoo sarebbe stato un rettangolo di silenzio, rotto solo dai sospiri dei pochi animali che attendevano il rincorrersi delle giornate nella solitudine delle proprie gabbie.
Avrebbero camminato tra una gabbia deserta e l’altra, avvicinandosi agli sguardi indifferenti degli animali, passando invisibili tra la folla.
– Non ti sembra triste? – gli avrebbe fatto notare Simona.
– Cosa? – avrebbe finto di non capire, lui.
– Tutto questo: le gabbie, la gente, gli animali…
– No – avrebbe detto, scrollando le spalle, – anzi, l’unica cosa triste di questo zoo mi sembrano gli umani.
Probabilmente lei lo avrebbe scambiato per matto, ma più probabilmente avrebbe riso di una risposta tanto strampalata.
– Gli umani?
– Oh, avanti, le uniche creature in gabbia siamo noi, sono loro – avrebbe risposto, indicando la gente, – persone rinchiuse in gabbie di tristezza, di solitudine, di repressione. Siamo noi quelli così patetici e disperati da aver inventato un Dio per poterci togliere le responsabilità delle nostre azioni, per poterci lavare la coscienza.
Simona probabilmete avrebbe ridacchiato, o forse no, forse si sarebbe fatta ancora più seria e avrebbe domandato: – Dio?
– Dio, la religione, la morale, la legge… queste secondo me sono le gabbie degli uomini.
Probabilmente avrebbe ridacchiato, forse avrebbe dubitato, o magari non avrebbe creduto: – Io non mi sento in gabbia, io sono libera.
– Sei più schiava di tutti gli schiavi di questo mondo, se credi veramente in quello che hai detto – avrebbe risposto lui.
– Se dici così allora anche tu sei in gabbia – avrebbe risposto lei. E a lui non sarebbe rimasto altro che vedere il peso della consapevolezza, nei suoi occhi lucidi, una consapevolezza tra tante, nella chiave di volta che regge l’universo-vita.
– Non ho mai detto il contrario – avrebbe sussurrato, prima di baciarla.