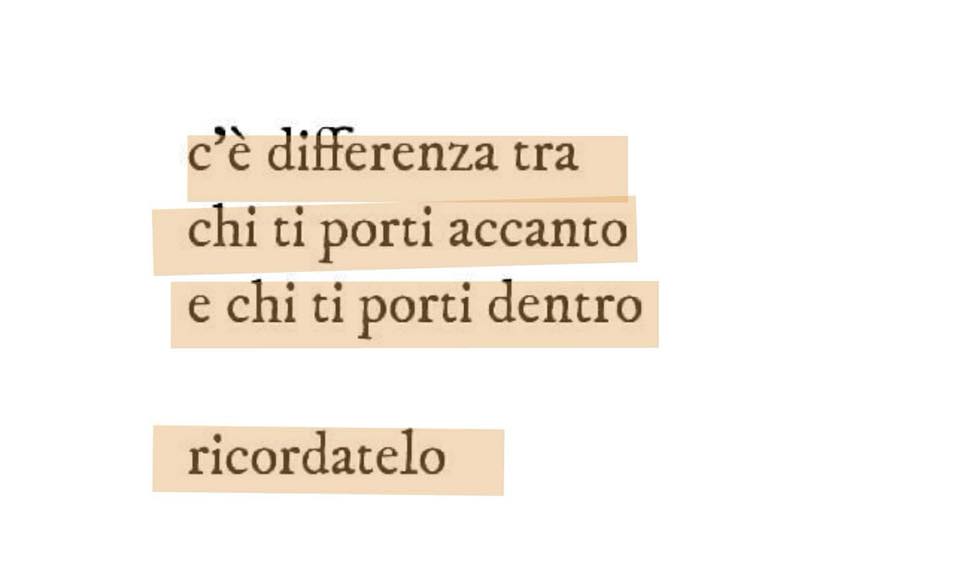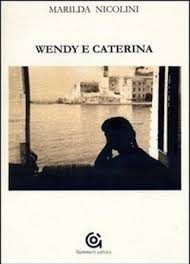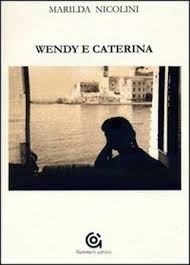Seconda parte.
Questo proposito gli diede sollievo e si assopì con questi pensieri, scivolò in un sonno agitato, fino a quando non entrò l’infermiera di turno con il vassoio del pranzo.
Era giovane e carina, minuta e fragile come un fiore, con grandi occhi scuri che brillavano come due gioielli ogni volta che gli sorrideva; il viso delicato era incorniciato da corti capelli scuri che la facevano sembrare una ragazzina.
Si chiamava Michela ed era la più affettuosa e premurosa di tutte.
Un giorno gli aveva confessato:
«Lei mi ricorda mio padre.»
Era forse per questo che lo trattava con una gentilezza squisita.
Naturalmente, tutti erano gentili e solleciti verso i pazienti, ma lei aveva qualcosa di speciale.
«Come si sente oggi Giuseppe, meglio?».
«Come il solito, da schifo» rispose, guardando con disgusto il vassoio che lei teneva in mano.
«Ha visto che tempaccio?»
«Sembra il diluvio universale».
«Adesso l’aiuto a scendere così mangia qualcosa», aggiunse lei gentile.
«Non ho fame, ho la nausea.»
«Deve sforzarsi di mandare giù il cibo, è normale avere nausea, è la terapia, e poi … non è contento?».
«Ho saputo che domani tornerà a casa».
«Così sembra», rispose Giuseppe mentre si accingeva a scendere da letto.
Michela aveva apparecchiato il piccolo tavolino quadrato che era posto davanti alla finestra dalla quale, attraverso le tende, s’intravedeva a tratti, il bagliore dei lampi.
Anche se era mezzogiorno, si era fatto buio da sembrare sera.
Accese la luce e gli mise sul tavolo una bottiglia di acqua fresca.
Giuseppe si sedette e guardò con vero disgusto il piatto di pasta, lo spezzatino e la frutta.
«Su, si sforzi di mangiare; torno più tardi» e uscì spingendo il carrello delle vivande, seguita dal collega Mauro che si era preoccupato di servire il paziente della stanza accanto, gli fece l’occhiolino e chiuse delicatamente la porta.
Giuseppe assaggiò la pasta, mise in bocca un po’ di spezzatino ma tutto aveva un sapore amaro e l’odore del cibo lo nauseò a tal punto che spinse via i piatti bruscamente e si alzò barcollando leggermente per andare in bagno.
«Che cosa serve mangiare se tra poco dovrò morire?» brontolò tra se.
Uscito dal bagno, tornò a letto e si assopì.
“… Pioveva a dirotto, l’acqua arrivava da ogni parte e saliva, impetuosa e minacciosa, torbida e scura, gli lambiva i fianchi e cercava di trascinarlo via con forza. Stava per essere travolto, quando vide il ramo di un albero che si tendeva verso di lui. Si sporse cercando di aggrapparsi all’improvvisata ancora di salvezza ma, il ramo si tramutò in un braccio con artigli, il viso cinereo di una ragazza spuntò dall’acqua melmosa, aveva occhi incavati e orbite vuote, la bocca si aprì ghignando. I piedi stavano perdendo la presa e precipitò nell’acqua scura sentendosi soffocare”.
«Giuseppe, Giuseppe!»
«Ti senti male?».
La voce preoccupata di don Luigi lo riportò alla realtà.
Madido di sudore freddo, con il cuore che gli pulsava nelle orecchie, guardò il sacerdote con sollievo.
«Ho avuto un incubo, che mi perseguita da mesi oramai … Ho bisogno di parlarti», sussurrò con un filo di voce, asciugandosi il viso con il fazzoletto che gli porgeva il prete.
«Lo sai che sono qui per aiutarti» ripose don Luigi accostando una sedia al letto.
«Prima dammi un po’ d’acqua, ho la gola secca e ruvida come carta vetrata».
Bevve con avidità alcuni sorsi e guardò il prete dicendo:
«Non so da dove incominciare.»
«Dall’inizio», lo incoraggiò don Luigi.
Parlò, prima con fatica, facendo lunghe pause, come per riordinare le idee.
Poi, tutto di un fiato, raccontò dell’incidente, dell’omissione di soccorso, della sua vigliaccheria, del suo egoismo, degli incubi ricorrenti, del litigio con Giulio, acquistando coraggio mano a mano che proseguiva.
Don Luigi lo ascoltò senza interromperlo, lo guardava con affetto e attenzione, stringendogli una mano.
Circa sei anni prima, Giuseppe, una sera d’autunno, stava tornando dal circolo ricreativo; era buio e pioveva a dirotto.
La pioggia batteva sull’auto come raffiche di una mitraglia, limitando la visibilità; il vento soffiava forte facendo ondeggiare alberi e insegne luminose.
Una vera tempesta che si stava portando via gli ultimi bagliori rossi e oro delle foglie degli alberi, lasciandoli andare, spogli, come scheletri impauriti, verso il freddo dell’inverno.
Le strade erano semideserte e, all’improvviso, gli era sembrato di aver urtato qualcosa, aveva sentito un botto, attutito dal rumore dell’acqua scrosciante.
Aveva rallentato, guardato attraverso il vetro posteriore appannato e gli era parso di vedere qualcosa per terra in mezzo alla strada.
La visibilità era scarsa e ne dedusse si trattasse di un ramo spezzato dalla tempesta o dell’ombra degli alberi che, mossi dal vento impetuoso e illuminati dalla luce giallognola dei lampioni del viale, s’impegnavano in una danza sfrenata come sagome di fantasmi impazziti.
Era tornato a casa, bagnato fradicio e infreddolito, stanco e nervoso dimenticando l’episodio.
Soltanto l’indomani aveva letto sul giornale, per caso, che un pirata della strada aveva investito una ragazza, proprio sul viale alberato che aveva attraversato la sera precedente.
Il luogo e l’orario coincidevano.
Era rimasto sconcertato, aveva comprato un altro quotidiano e seguito la storia nei giorni seguenti e, quando aveva letto che la ragazza aveva battuto la testa, era ricoverata in ospedale ma non era in pericolo di vita, lasciando da parte rimorsi, sensi di colpa e dovere civico, era tornato alla vita di sempre.
Non aveva detto niente a nessuno, neanche a Giulio e poco alla volta aveva dimenticato l’episodio.
Ora questo ricordo lo tormentava e gli procurava incubi agghiaccianti. Si chiedeva spesso se la ragazza stesse bene, chi fosse, dove vivesse.