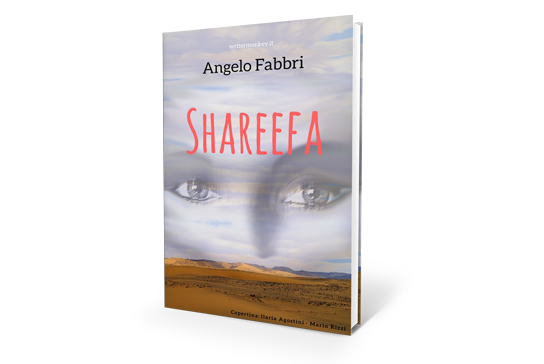Per Amelia
Quando vivevo da sola con la mamma ero felice. O perlomeno serena. Vivevamo in un casolare di campagna, un pò troppo isolato per chi ama la compagnia, ma io ci stavo bene. Assaporavo la natura e tutto quello che ci offriva… grazie alla mia sfrenata fantasia tutto ciò che avevo davanti acquistava una sua dimensione ed un suo carattere. Tutto prendeva vita, diventava una storia con personaggi, nomi, eventi che accompagnavano lo scorrere del tempo e mi aiutavano a vincere la monotonia della vita di campagna. Tutti i miei animali che, ad un qualsiasi osservatore estraneo sarebbero sembrati pressoché identici, perché di fatto lo erano, per me custodivano un vissuto, un passato, un carattere, un amore, un futuro.
La mamma era una donna asciutta, non molto affettuosa. Doveva aver avuto una vita dura, non ho mai conosciuto il suo passato e chi fosse realmente. Se dovessi descriverla non ci riuscirei, perché non lasciava trapelare le sue emozioni. Le parole erano per i ricchi, così diceva… comunque si prendeva cura di me e mi stava vicino. Fu proprio per quel senso del dovere, quel suo prendersi cura, che decise di sposare un vedovo, nella speranza di assicurarci un futuro migliore, visto che non avevamo molti soldi. Così di punto in bianco mi ritrovai sul groppone un padre ed una sorella più grande. Accettai la notizia di buon grado, convinta che quell’evento potesse essere migliorativo. Soprattutto l’idea del padre mi rendeva felice, perché non sapevo chi fosse il mio, anzi, per essere precisi, non sapevo che per forza di cose tutti i bambini per venire al mondo dovessero averne uno. Credevo fosse una specie di optional, una figura marginale, inventata più per dare fastidio che per l’ utilità di qualcuno.
Il mio entusiasmo per questa figura paterna fu smorzato non appena conobbi l’uomo che mia madre aveva scelto. Era burbero, dai modi grossolani, le mani tozze, callose, grandi. Ci tenne a chiarire sin da subito che mai e poi mai avrei dovuto chiamarlo “papà” ma solo “signor Carlo”. Avrei dovuto obbedirgli senza fiatare perché ero una bastarda senza padre.
La mia sorella acquisita era carina con me, anche se mi trattava come un essere inferiore. Si chiamava Cecilia. Esteticamente era molto bella e formosa, sembrava avere una calamita che attirava tutti gli uomini. Era poco più che adolescente quando venne adocchiata da un vicino di casa che avevamo soprannominato “il lupo”. Quando ne fiutava la presenza il lupo si appostava come un predatore, le tendeva sordidi agguati nei vicoli di campagna, la spiaccicava contro il muro, le tappava la bocca con una mano mentre con l’altra cercava prepotentemente di intrufolarsi nelle sue mutandine di cotone, violandone l’innocenza. Quando tornava a casa Cecilia, rossa e trafelata, mi raccontava tutto, solo e soltanto a me, sua sorella acquisita di sei anni più piccola. Ero angosciata e atterrita da quei racconti; desideravo solo che il lupo potesse sparire dalle nostre vite per non doverli più ascoltare, per dimenticare il brutto sapore di quelli squallidi approcci, per non dover tremare ogni volta che mia sorella usciva da casa e non tornava. Contrariamente a me, Cecilia non sembrava eccessivamente turbata da quegli incontri. Sembrava divertita dall’amore: conscia del fascino e del potere che esercitava sugli uomini, giocava con loro come con dei soldatini umani. Continuava a raccontarmi tutto Cecilia; io ero praticamente una bambina, e in me si stava formando una cultura distorta sull’amore e sul sesso, fatto di lessico volgare, fin troppo ricco e variegato. A me sembrava tutto incredibilmente brutto e sporco. E poi non capivo perché mia sorella cambiasse fidanzati più o meno con la stessa frequenza con cui si cambiava le mutande. Non mi sembrava mai innamorata di nessuno, se non di se stessa. Ancora mi chiedo se fosse in grado di giocare la sua partita a scacchi con gli uomini, oppure se fosse semplicemente una pedina, incapace di un rifiuto.
Ben presto il signor Carlo venne a conoscenza delle chiacchiere che giravano in paese sul conto di sua figlia, per cui decise di correre ai ripari e costrinse la medesima, a suon di ceffoni, a sposare un tizio scelto da lui in base ai suoi requisiti. Quel tizio, se pur grandicello, viveva e lavorava con i suoi genitori nel negozio di alimentari a gestione familiare. Era rigido come un manichino e si comportava come uno dei suoi insaccati. Era imbalsamato alla vita, appeso come un salame al gancio di un vincolo familiare da cui non riusciva (o non voleva) liberarsi. Cecilia lo chiamava il mortadellaro. Nonostante fosse evidente che non provava la pur minima attrazione verso l’insaccato gigante, fu costretta a sposarlo. Così Cecilia ed il suo marito-manichino se ne andarono a vivere in città, lontano da noi e dalla vita di campagna.
Io rimasi di nuovo sola. Avevo 12 anni. Il signor Carlo mi impose di non andare più a scuola, avevo la licenza elementare e ciò secondo lui bastava, tanto avrei solo dovuto prendermi cura della casa e della campagna ed assecondare i suoi capricci. Anche se trascorrevo la maggior parte del mio tempo libero nel fienile con i miei animali e le loro storie inventate, l’avere una sorella, se pur per pochi anni, mi aveva messo in contatto con il mondo reale, con la gente mi piaceva andare in paese, avevo imparato a vestirmi un pò meglio, ascoltavo sempre le canzonette e non smettevo mai di canticchiare.
Fino al mio 11 settembre, il giorno in cui la mia, già in prospettiva squallida vita, andò in frantumi, sgretolandosi irrimediabilmente in mille pezzi per il resto dell’eternità.
Era una tranquilla sera settembrina, avevo indossato il mio vestito buono ed avevo fatto una breve passeggiata in paese con mia madre ed il sig. Carlo perché c’era la festa del santo patrono e volevamo assistere, come tutti gli altri paesani, ai fuochi artificiali. La festa di paese è uno dei pochi svaghi tanto attesi nella monotonia della vita di campagna, gli uomini sono un po’ brilli e le ragazze si guardano in giro furtive, in cerca di un marito papabile. A me non interessava nulla di tutto ciò… fantasticavo guardando quelle luci e quei colori, immaginando di essere altrove. Ma il tempo era scuro, minaccioso, così ci fu un fuggi fuggi generale e, in barba ai fuochi artificiali, ognuno pensò bene di ritirarsi a casa prima che scoppiasse il diluvio. Infatti ero appena entrata nel fienile a salutare i miei animali quando iniziò un violento temporale, con lampi, tuoni, fulmini e pioggia battente. Ad un certo punto un rumore mi fece sussultare, la porta si aprì violentemente ma non per il temporale. Entrò il lupo…ubriaco… con altri due uomini. Quello che successe dopo non voglio descriverlo, è un orrore che non va condiviso, lo squallore è soltanto mio. In questo caso è sufficiente il silenzio… quello che fa rumore… e tutti capiscono tutto.
Quando riuscii a raccogliere i cocci di me stessa, barcollando entrai in casa. Il signor Carlo e mia madre stavano cenando. Bastò uno sguardo sulle mie lacrime e sul mio vestito buono ridotto a brandelli per far sì che mia madre capisse tutto. Istintivamente si alzò per corrermi incontro, ma bastò un cenno della mano del sig. Carlo per farla desistere. Si rimise a sedere, triste e mesta, con il capo chino, come un cane bastonato. Non osava guardarmi per il senso di colpa di chi soffoca il proprio amore materno per sottostare al volere indiscusso di un marito padrone. Mi fece pena quella donna fantoccio, senza volontà.
Il sig. Carlo iniziò un discorso contorto, strampalato, il succo del quale era riconducibile al fatto che ciò che mi era successo era brutto, certo, ma quasi normale, bisognava capire quei poveri paesani che lavoravano duramente senza “svaghi”. Poi io ero un po’ troppo in carne per la mia età e quel vestito esaltava le mie forme procaci. Forse se mi fossi vestita in maniera diversa tutto ciò non sarebbe successo. Così mi disse di non parlarne con nessuno e mi lanciò una banconota da 50.000 lire per risarcire il mio vestito e la mia anima a brandelli. Cercai lo sguardo di mia madre ma era perso. Guardai negli occhi il signor Carlo per chiedergli se nel negozio dove avrei dovuto comprare il vestito nuovo “adatto a me” avrei trovato anche un cuore, pezzi di dignità, fiducia, sicurezza, autostima e, perché no, magari anche una vagina nuova. Avrei voluto dire a quell’uomo insensibile e alla mia mamma fantoccio che io non avevo più nulla. Ma non ebbi il coraggio e decisi di non parlare mai più con loro; forse il mio silenzio e la mia ingombrante presenza prima o poi avrebbero scatenato in loro almeno una nota di rimorso. O forse erano troppo egoisti ed insensibili per provare sentimenti buoni. E poi giurai a me stessa che nessuno mi avrebbe toccato… mai più. Mi rifugiai nel fienile che diventò il mio porto sicuro e decisi di trascorrere lì, con la mia fantasia ed i miei animali, il resto della mia esistenza.
Ma passarono i mesi e mi accorsi che qualcosa non andava; non ero più la stessa, stavo male, vomitavo e continuavo ad ingrassare. Quando arrivò Cecilia con il manichino ci volle poco ad arrivare al nocciolo della questione. Li sentii confabulare vivacemente con mia madre finché si decisero a portarmi da un medico nella città dove Cecilia abitava. Quello fu l’unico viaggio della mia vita. Per un attimo riuscii a guardare il mare da lontano e sognare. Secondo alcune leggende il mare è la dimora di tutto ciò che abbiamo perduto, di quello che non abbiamo avuto, dei desideri infranti, delle lacrime che abbiamo versato. In quel momento avrei voluto saltare fuori dalla macchina e tuffarmi per ricongiungermi al mare, per trovare un pò di pace.
Tornando alla realtà, dopo la visita medica, Cecilia mi disse che ero incinta. Non fu una novità per me; nell’ignoranza della mia vita mesta, nel silenzio della mia solitudine, nella mancanza di contatti umani, nell’abitudine a non far rumore io il rumore ce l’avevo dentro. Era il rumore di una nuova vita. Forse il mare, che solo per un attimo avevo guardato da lontano, per ricompensarmi di tutto quello che avevo perso e mai avuto, mi mandava un dono. Il dono di un bambino. Ovviamente non sapevo di quale dei tre scellerati fosse il seme che lo aveva generato, ma non mi importava, sarebbe stato solo e soltanto mio. Adesso la mia inutile vita aveva un senso.
Purtroppo al ritorno a casa non accadde ciò che mi aspettavo. Ci furono urla, pianti, scene isteriche, melodrammi. Il signor Carlo mi prese a sberle, diceva di essere capitato in una casa dove si generavano solo bastardi.
Io, nonostante ciò che avevo passato, non capivo; in fondo non era morto nessuno, avevamo una nuova vita che non poteva portarci altro che gioia. Non capivo la vergogna di mia madre, l’indignazione del signor Carlo, lo sdegno del manichino. Ancora una volta tutti si comportavano come se fosse solo e soltanto colpa mia. Per loro, esseri ottusi, quello che portavo in grembo non era un bambino come gli altri, ma il figlio della vergogna; lo chiamavano il “coso”, addossandogli colpe che non aveva. Ma io, in cuor mio ero convinta che il “coso”, una volta nato, potesse imporre la sua presenza nel mondo, riuscendo a farsi amare, incondizionatamente, da tutti noi. Anche dal sig. Carlo. E sarebbe rimasto con me per sempre.
Quando partorii non rimasi da sola. Cecilia si prese cura di me. Mentre mia madre era più preoccupata che non facessi rumore e non disturbassi la pennichella del signor Carlo, Cecilia, se pur impaurita e non sapendo bene cosa fare, cercava di darmi conforto tramite la musica. Mi faceva ascoltare delle canzoni per cercare di distrarmi e allo stesso tempo di coprire le mie urla. Una canzone in particolare mi colpì… si chiamava The sound of silence. Cecilia mi spiegò che la cantavano due tizi americani, uno si chiamava Simon e l’altro aveva un nome impronunciabile che iniziava con la G. Uno era scuro e piccoletto, l’altro alto, biondo e allampanato. Non sapeva chi fosse l’uno o l’altro o perlomeno in quel momento non era in grado di ricordarselo perché troppo impegnata a dar coraggio a me senza svenire, ma poiché in città si era messa a studiare l’inglese era in grado di tradurre quella che sarebbe diventata la mia canzone preferita.
“Salve oscurità, mia vecchia amica, ho ripreso a parlarti ancora, perché una visione che fa dolcemente rabbrividire ha lasciato in me i suoi semi mentre dormivo e la visione che è stata piantata nel mio cervello ancora persiste nel suono del silenzio…
…Nei sogni agitati io camminavo solo, attraverso strade strette e ciottolose, nell’alone della luce dei lampioni, sollevando il bavero contro il freddo e l’umidità, quando i miei occhi furono colpiti dal flash di una luce al neon che attraversò la notte… e toccò il suono del silenzio… E nella luce pura vidi migliaia di persone, o forse più, persone che parlavano senza emettere suoni, persone che ascoltavano senza udire, persone che scrivevano canzoni che le voci non avrebbero mai cantato e nessuno osava, disturbare il suono del silenzio….”
Era la voce della mia canzone, della mia solitudine, del mio “coso”, frutto di una notte da incubo, della mia non voglia di relazionarmi con le persone, del mio silenzio e del rumore che avevo dentro. Era stata scritta per me. Avrei voluto ringraziare quei due tizi, Simon e G, che pur non conoscendomi avevano espresso e cullato il mio dolore con la loro dolce melodia.
Con le note di The sound of silence finalmente nacque il coso. Non me lo fecero neanche vedere, lo portarono subito via. Mi dissero che era un maschio; non dovevo preoccuparmi di dargli un nome perché era stato male, lo avevano portato in ospedale ed era morto. Iniziai ad urlare ed insultare tutti perché non credetti ad una sola parola di quell’assurda spiegazione. Sapevo che il mio bambino era vivo e me lo avevano portato via. Secondo loro ero troppo giovane e troppo stupida per fare la mamma. Cercai un po’ di conforto in Cecilia, ma era sparita improvvisamente anche lei, senza neanche salutare.
Così senza emettere un fiato, tornai a vivere nel fienile, nell’oscurità mia vecchia vita e nel suono del silenzio. Continuavo a lavorare in campagna ma non passava un solo giorno in cui non pensassi almeno per un istante al mio bambino. Scrissi a Cecilia per sapere qualcosa ma non mi rispose. Sembrava svanita nel nulla. Io ero sempre più triste e sempre più isolata. La gente non mi interessava. Il lupo, tronfio della sua mascolinità, aveva provato ad entrare nel mio porto sicuro, ma era scappato via a gambe levate visto che questa volta avevo reagito cercando di infilzarlo con un forcone. In paese aveva diffuso la voce che fossi matta e nessuno osava più avvicinarmi. Anche mia madre, che avrebbe dovuto istintivamente proteggermi, creando intorno a me un’impercettibile barriera di amore materno, mi trattava con distacco, forse perché non riusciva a far fronte alla sua inutilità e al suo senso di colpa.
Un bel giorno, dopo circa due anni, di punto in bianco ricomparve mia sorella Cecilia, con il suo manichino ed una bimbetta bionda, riccioluta, che spacciavano per loro figlia. Mi bastò uno sguardo per capire tutto. La bimba si chiamava Amelia ed era identica a me. Era il mio “coso”. Quello che mi avevano fatto credere morto. Quello nato al suono del mio silenzio. Quello che non avevo mai visto. Quello che mi avevano rubato. Avrei voluto dire mille parole ma non ne pronunciai neanche una; bastò uno sguardo perché Cecilia capisse che avevo capito… bastò uno sguardo perché gli occhi sono più sinceri delle parole. Cecilia disse che era dispiaciuta… lei non avrebbe voluto fare la mamma in prestito ma il sig. Carlo glielo aveva imposto, così come tutto il resto della sua vita, marito compreso. Lei, Cecilia, aveva sempre detto troppi sì.
D’altronde se la bambina avesse vissuto in campagna con me che razza di vita avrebbe avuto? Infelice come la sua o sprecata come la mia? Se le fosse andata bene si sarebbe sposata con un marito imposto… un manichino, un Carlo o un lupo. Cecilia mi promise che a te, figlia mia, avrebbe dato una vita degna, ti avrebbe fatto studiare in modo che non saresti stata la donna ignorante che non poteva parlare a cui veniva imposto tutto e forse un giorno avresti avuto un uomo fantastico, magari un poeta… perché la sensibilità non è propria solo della donna… ma è umana… e se la si trova in un uomo diventa pura poesia. Questo è quello che avrei voluto per te.
Cecilia mi promise che ci saremmo viste spesso, ma non avrei dovuto mai dirti la verità perché se il sig. Carlo l’avesse saputo ci avrebbe separate per sempre. Infatti egli, il mio non padre padrone, non voleva che mi avvicinassi alla bambina. Sosteneva, per mascherare la sua paura, che ti dicessi la verità, che la mia pazzia o presunta tale potesse essere contagiosa; non sapeva lo sciocco che l’indissolubile legame madre/figlia va al di là di qualsiasi ragionevole o irragionevole motivazione. Tu, Amelia, eri attratta da me come una calamita e, non appena arrivavi, il tuo primo pensiero era venire nel fienile a trovare la zia fata straniera ed i suoi animali.
Passavano gli anni e la mia vita scorreva sempre uguale. Non cambiava nulla. Mi rendevo conto che ognuno è artefice del proprio destino, per cui tante volte pianificavo fughe che non si realizzavano mai, perché ne trovavo sempre altre, più o meno banali per rimanere dov’ero. Prevaleva la paura, la rassegnazione, l’impotenza. Dicevo a me stessa che doveva per forza accadere: sarei fuggita lontano, ma magari non troppo… sarei scappata di notte … o meglio all’alba… e sarei andata a destra… o forse a sinistra… perché la strada era più bella…perché non c’erano macchine… e non c’erano ombre… sarei fuggita d’inverno… o con la pioggia d’estate… perché era più facile… e perché prima o poi sarebbe uscito il sole.
Ma non l’ho mai fatto; il treno della vita a volte non basta solo prenderlo, bisogna guidarlo ed io non ne sono stata capace… Così ho lasciato che la vita mi scivolasse via dalle mani. Come unico conforto sfioravo una tua foto con le dita immaginando come sarebbe stato se…
Tu, figlia mia adorata, non hai mai trovato il tuo sensibile poeta, che avevo tanto sognato per te, ed io mi sono colpevolizzata anche di questo, convinta che anche i sentimenti siano ereditari, convinta di averti trasmesso la paura e l’inadeguatezza che provavo io verso l’altro sesso. Spero un giorno mi perdonerai per questo mio DNA sbagliato. Spero che mi perdonerai per la viltà di non averti tenuto con me, di non aver cambiato la mia vita, di non averti detto mai la verità. Spero un giorno mi perdonerai perché la mia morte non è un caso, ma è voluta, desiderata; ho accumulato pillola su pillola sino ad essere sicura che se le avessi prese tutte insieme mi avrebbero fatto secca. E così è stato. A volte si muore non quando il cuore cessa di battere ma quando i battiti non hanno più senso… Ed io ero morta già da tempo.
Volevo chiedere scusa a tutti coloro che in questi anni ho fatto disperare. Per alcuni di loro ero solo Olga la matta, che urlava col temporale, che non si faceva toccare, che non era capace a mangiare da sola, che si sporcava e non sapeva pulirsi, che era sempre in silenzio. Ma anche Olga la matta ha avuto una vita, un tempo è stata bambina, ragazza, donna. A volte ho l’impressione che alcuni di voi pensino che noi vecchi siamo nati vecchi, senza un passato, senza un vissuto.
Vi prego, affinate la vostra sensibilità e cercate di comprendere che dietro a quel viso rugoso dell’anziano malato che dovete imboccare perché non riesce a mangiare, che dovete accompagnare perché non riesce ad orientarsi, che dovete vestire e spostare perché non riesce a muoversi, di cui dovete comprenderne i bisogni perché non riesce a comunicare, c’è una persona con un’anima vera. Se capite questo il vostro lavoro vi arricchirà e vi farà diventare persone migliori.
Spero che tu, bambina mia, stia leggendo questa lettera e spero che tu capisca che non è trascorso un solo istante della mia vita in cui io non ti abbia amato. Ma ti prego non fare come me, fa le tue scelte… coraggiose e non… e goditi la vita.
Olga, la tua vera, unica mamma