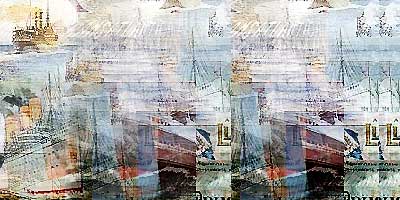Le pareti di questo piroscafo sono di acciaio, ripide come montagne, bianche come i fantasmi che sognavo nella nebbia la mattina, quando uscivo di casa al primo albeggiare e camminavo per raggiungere i campi, la vanga sulle spalle e una bisaccia con pane e formaggio al collo, il mio pasto fino alla sera.
Adesso vedo soltanto il grigio sotto i miei piedi e il blu del mare che si perde in lontananza.
Io non avevo mai visto il mare, cioè sapevo com’era perché la maestra a scuola ci aveva fatto vedere le illustrazioni, ma credevo fosse una distesa piatta, immobile come l’erba, tutt’al più rigata dal vento, anche se non avevo mai pensato che il vento potesse soffiare anche lì. Da dove veniva il vento? Dove andava? A casa mia sapevo che poteva venire dalle montagne, freddo e secco, oppure dalla pianura, carico di acqua, ma lì? E poi una cosa è sempre diversa quando la vedi da come l’hai immaginata.
C’è gente sul molo, gente che si agita, si saluta. Io sono solo, ma molti sono con i genitori, la fidanzata, ed allora le scene sono molto tristi: piangono si disperano, si abbracciano e si lasciano cento e cento volte. Meglio non avere neanche un cane con te, anche se mi sarebbe piaciuto accarezzare ancora una volta il vecchio Fido, il cane da caccia di mio padre. Chissà se lo rivedrò mai più, non credo.
Sono salito tra i primi, non sopportavo tutti quei pianti, e sopra la situazione è molto più tranquilla. C’è un ragazzo che sta da solo, in silenzio. Indossa una camicia a quadri, troppo pesante sotto questo sole, è alto, muscoloso ma sembra volersi rannicchiare dentro se stesso, come se volesse sparire. Vorrei parlargli, ma non so cosa dire, ed allora faccio girare lo sguardo sul pavimento della nave – tolda, si chiama tolda, mi hanno detto, che nome strano – e noto che il metallo spunta a tratti dalla vernice screpolata e data alla buona. Sono sicuro che io avrei saputo fare meglio: quando ho verniciato il granaio…
Ricordi.
Mi hanno raccontato che il viaggio durerà più della metà di un mese, anche a seconda delle condizioni del tempo. Mi sembra impossibile che una barca così grande possa essere ritardata da un temporale, ma me l’ha raccontato un marinaio alla locanda, ieri sera, e non lo faceva per spaventarmi. Per loro è normale, è un lavoro come gli altri, ma io a volte mi trovo a chiedermi come sarà avere sotto di sé soltanto l’acqua, quest’acqua che non sta mai ferma.
Riderai quando leggerai quello che ti scrivo, ma devi credermi: qui ci sono le cose più strane. Ho visto sequestrare di tutto, anche una gabbia di polli, una gabbia di legno che un disgraziato come me si stava portando dietro. Subito ho riso, come gli altri, ma poi ho pensato che quei polli magari erano stati un sacrificio della sua famiglia, ed allora mi è venuta tristezza. Quante storie ci portiamo dietro, quante speranze! Io non so fare niente altro che coltivare la terra, ed allora mi sono detto: perché andare a Nuova York, nella Merica del Nord, dove tutto è moderno, dove le macchine fanno il lavoro di cento uomini? No, per noi cafoni è meglio la Merica del Sud, l’Argentina dove la terra è tanta e la gente poca, o forse il Cile, dove ci sono degli amici che mi hanno preceduto. Forse, perché sono anni che non ho più notizie di loro. Ma il Cile, l’Argentina, per grandi che siano non saranno infiniti, no?
«Ciao» dico al ragazzo seduto in terra vicino a me. Lui non mi risponde, ma quando ripeto il saluto mi restituisce un “ciao” un po’ imbronciato.
«Anche tu viaggi da solo?» gli chiedo.
«Sì»:
«Di dove sei? Io sono piemontese, Basaluzzo, conosci?».
Mi fa cenno di no.
«Basso Piemonte» preciso «vicino ad Alessandria».
Questo gli ricorda qualcosa, un poco si sgela.
«Io vengo dalle Marche, un paese che si chiama Mercatino».
«Allora sei già a metà strada!» scherzo.
Lui mi guarda incerto, non capisce se lo sto prendendo in giro.
«Mi chiamo Tommaso» gli dico, porgendogli la mano.
Dopo un istante mi dà la sua, ruvida, callosa. Come la mia.
«Luigi».
«Anche tu contadino?».
«Sì».
«Terra magra?».
Alza le spalle.
«In famiglia siamo tutti braccianti» mi spiega «non c’era da mangiare per tutti».
È un po’ il destino comune: si emigra per cercare lavoro, per fame, per disperazione. Pochi lo fanno inseguendo un sogno, quello lo scrivono soltanto nei libri.
Io, contrariamente ai miei fratelli, un poco so leggere e scrivere, e questo ha contribuito alla scelta di fare espatriare me, ‘perché avrei imparato più facilmente l’inglese’. Ma dove vado l’inglese non serve, lo spagnolo è facile, se parlano lento.
Un brivido scuote la nave, sento i marinai lanciarsi delle grida. Rumore di ancore che vengono salpate. Io e Luigi ci guardiamo negli occhi e un lampo di terrore ci unisce.
«Il mare mi fa paura» confessa lui.
«Anche a me» rispondo «pensa che non so neanche nuotare».
«Neanche io».
«Allora siamo proprio ben presi!» esclamo «ma dicono che tanto in mezzo al mare non fa differenza».
Mi guarda dubbioso.
«Va bene, non ci credo neanche io!» concedo, e rido.
Questa volta si unisce alla mia risata. Si alza e prende la sua roba.
«Dai, andiamo di sotto, altrimenti non troveremo posto».
«Non c’è posto per tutti?» gli chiedo, incredulo «ma io ho pagato il biglietto!».
«Certo, anche io. Ma mi dicono che la terza classe è un carnaio, e i primi si prendono le brande migliori. O le cuccette, non so».
Mi carico la mia roba sulle spalle.
«Allora andiamo, dai!».
Entriamo dalla porta stagna, lui prima e io dopo. Quanto sto per inoltrarmi nella semioscurità mi volto ancora indietro, e vedo che la nave si sta scostando dal molo.
«Non ti preoccupare, di mare ne vedrai quanto vuoi!» mi sbeffeggia un marinaio che sorveglia le operazioni.
Non rispondo e seguo il mio nuovo amico giù per le ripide scale metalliche, nel ventre della balena. Sento lo stomaco stretto in una morsa, il cuore che mi si fa piccolo. La sensazione di non poter più tornare indietro. Mai più, forse.
Il viaggio è cominciato.