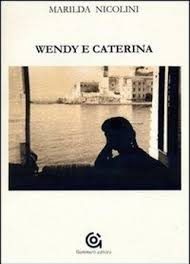La città è triste quando non puoi permetterti un eye-contact nella metropolitana fatta di odori stranieri, di cuffie ben indossate a prova di rumore di acciaio che sfrigola, di occhi scuri e ostili che ti guardano e che in realtà erano il tuo riflesso su un vetro istoriato da artisti in erba, di due adolescenti che si prendono per mano e che li odio e li invidio e probabilmente hanno sentito il mio telepatico livore e quindi avvicinano le proprie labbra incuranti di ciò che è stato e ciò che verrà.
Gli innamoratini innescano il rifrullo a trentacinque chilometri all’ora e spero che al più presto possano viaggiare in aereo, se l’amore è legato alla quantità di moto. Forse lo è.
La cantilena della strada ferrata si ferma ad una stazione, e la stazione mi ricorda Dennis. Ho una stretta al cuore. Quanto tempo è passato da allora. Non erano tempi migliori di questi, erano solo diversi. Stessi ingredienti (persone, confusione, metro) ma abitudini differenti e assenza dell’accoppiata sguardo fisso-smartphone.
Lavoravo in centro, e spesso ero costretto dal signor Caos a spostarmi con i mezzi pubblici con percorsi molto simili ai “design patterns” di Gamma e la gang dei quattro, configurazioni sempre uguali ma sempre differenti e applicabili a qualsiasi tratta (metro-bus-metro, bus-bus-metro, bus-metro-bus, metro-metro-e basta perché vent’anni fa a Roma ce n’erano solo due). All’uscita di una stazione, e sempre della stessa, c’era Dennis. Un clochard, con una straordinaria somiglianza ad un famoso attore.
Aveva i capelli lunghi, più sale che pepe, un’età purtroppo non definibile a priori e un cane come lui: pelo lungo, imbiancato dalla neve della vita, e uno sguardo stanco. Dennis non era il suo vero nome, e l’appellativo che gli avevo vestito addosso non rendeva giustizia alla sua dignità: anche se anziano e abbattuto manteneva un atteggiamento decoroso, da vero signore. E questo mi colpì la prima volta che lo vidi, in un giorno di pioggia. Ero reduce da tempo vissuto in Inghilterra, ed assorbite le albioniche usanze disdegnanti il parapioggia camminavo a passo semispedito che si affievolì al contatto visivo, prima con il suo cane e poi con i suoi splendidi occhi cerulei. Mi fermai, cercai denaro nelle tasche, e avevo una banconota da cinquemila lire, di quelle verdi con sopra il volto del giovine Bellini. La misi nel suo cappello e continuai a semispedirmi verso la destinazione senza guardare indietro.
Lo incontravo spesso, Dennis il clochard. Nel solito posto. Il suo cane era sempre accucciato con le zampe incrociate, come in un pisolino, che però tradiva la sua stanchezza di vivere. Dennis salutava sempre, che io donassi oppure no. Non sorrideva, ma non era ostile. Mi riconosceva ogni volta. Non posso dimostrarlo davanti a giudice e giuria, ma ne sono sicuro, ci guardavamo negli occhi e ci salutavamo senza parlare, un clochard al centro di roma e un trentenne spilungo con gli occhiali da sole neri. Andò avanti per un bel po’, con caldo e freddo, pioggia e sole, vuoto pneumatico o densità di bipedi, sciopero o non sciopero dei mezzi. Dennis viveva lì, con il suo cane senza nome.
Un giorno, andando a prendere la metro, Dennis era da solo. Non posso spiegare cosa provai, ma non riuscii a parlargli con gli occhi. Lo guardai, ma Dennis guardava in basso, senza espressione. Non mi salutò. Misi un biglietto da mille nel suo cappello, avvicinandomi per farmi notare, senza esito. Fu l’ultima volta che lo vidi.
La stazione di Dennis ormai è andata via, l’acciaio urla ancora e tutti guardiamo il nostro smartphone, che ci accomuna e ci divide, persi nella musica che cerca di addolcire le distanze vere, apparenti e costruite. Arrivo a destinazione, e penso che l’amore, l’affetto e la compagnia non hanno canoni o forme, e che Dennis stia correndo nei Campi Elisi insieme al suo cane, ridendo di me perché, con lo sguardo, non sono riuscito a carpirne il nome.