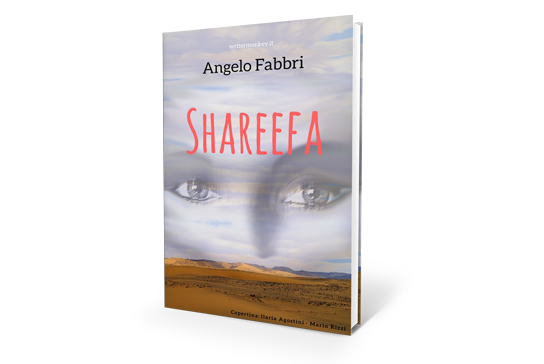1.
Il mio nome è Shareefa, la Rossa. La mia storia è tutta qui, in questa pianura dove sono nata, dove il vento a volte sussurra e a volte urla tra le rocce che spuntano dalla terra, dove il sole brucia e l’ombra accarezza.
Ero una bambina come tante altre nella Striscia, magri fagotti di stracci tra la polvere delle strade e i cespugli spinosi dei giardini. Abitavamo in un piccolo villaggio vicino a Beit Hanoun che non aveva conosciuto altro che la guerra e a cui la guerra aveva tolto tutto, ma per noi che non avevamo visto altro era tutto il mondo e nella nostra fantasia ogni cosa era un gioco, le pietre, una pozza d’acqua fangosa, gli scheletri dei palazzi sventrati dalle bombe.
I miei genitori vivevano come tutti, giorno per giorno. Mio padre lavorava per il Centro alla Moschea, un impiego poco più che fittizio per giustificare un magro sussidio da parte dell’Autorità, ma che a noi sembrava importante; mia madre tirava su me e i miei fratelli come poteva: io ero l’unica femmina. Era miseria, ma ci eravamo abituati. Niente era scontato, né il cibo che mangiavamo né l’acqua che dovevamo andare a prendere nei pozzi e portare a casa con i secchi.
Ci si lavava come e quando si poteva, i capelli solo la sera prima delle feste, ma poi li profumavamo con unguenti che le anziane ricavavano dalle piante, ed erano bellissimi. Non c’era televisione, non c’era neanche l’elettricità, a dire il vero, ma il cielo stellato era magico e passavamo le sere a leggere il futuro nel firmamento.
La vita scorreva lenta, ripetendo ogni giorno gli stessi gesti che scandivano un’esistenza senza speranze, eppure quieta. Il momento peggiore era all’imbrunire, quando i giovani dovevano partire per andare a piedi fino a Gaza City, ai mercati generali, otto lunghi chilometri da percorrere al buio per cercare un lavoro da scaricatori nelle ultime ore della notte: pochi soldi, ma necessari per tirare avanti e magari comprare una sciarpa da regalare alle ragazze: anche nella Striscia si amava e si faceva finta di credere nel domani.
Eravamo vicino al confine, e a volte nel primo buio della notte capitava che arrivassero grossi fuoristrada, da cui scendevano uomini che si appostavano sulla collina sopra al villaggio e si nascondevano tra i cespugli per sparare da lontano a tutto quello che si muoveva. Uno dei compiti di noi bambine era proprio quello di ascoltare il fruscio dei grossi motori silenziati e dare l’allarme: avevamo buoni occhi ed eravamo piccole, agili come gatti del deserto. Anche quello era un gioco, perché gli attacchi avvenivano raramente e riuscivamo sempre a dare l’allarme in tempo, a volte ancora prima che i veicoli fossero fermi. Gli assassini restavano un po’ in agguato, sparavano qualche colpo sulla piana immobile a qualche cane che si avventurava ignaro e poi ripartivano prima che la notte calasse completamente, orgogliosi della loro bravata e prima che qualcuno trovasse il coraggio di sfruttare l’oscurità per avvicinarsi e reagire, cosa che peraltro nessuno aveva mai fatto perché non avevamo armi, al villaggio.
2.
Le ombre si inseguivano come sempre, quella sera maledetta in cui tutto ebbe inizio. Ricordo che ascoltavamo i rumori lontani, giocando a chi riusciva per prima a individuare quale animale fosse a lanciare il suo richiamo alla luna. Io avevo tra le mani la bambola di pezza che tenevo sempre con me, era il regalo che mi aveva fatto mio fratello Ahmed per il compleanno, il mese prima, e non me ne staccavo mai. Improvvisamente una di noi alzò la testa e avvertì il rombo soffocato dei motori. Ci mettemmo in ascolto come sempre e avvisammo i ragazzi, che imprecarono contro quei bastardi che gli facevano perdere tempo e li avrebbero costretti a correre per arrivare in orario al lavoro.
Tutto nella notte divenne silenzioso, anche gli animali, disturbati, tacevano.
Il tempo passava lento, adesso aspettavamo con il fiato sospeso perché se fino a poco prima quello ci era sembrato un gioco, sapevamo dalla tensione degli adulti che la morte si aggirava tra di noi.
Come le altre volte ci furono lunghi momenti di silenzio, poi alcuni spari squarciarono il buio. Sentimmo le pallottole colpire le pietre e rimbalzare tra le case come sassate che si perdevano lontano.
Finalmente udimmo in lontananza il rumore soffocate di portiere che venivano sbattute, poi uno, due motori che venivano accesi e il rumore dei pneumatici sulla strada sconnessa delle colline. Calò un silenzio assoluto, la notte era irreale.
La memoria ritorna sempre a quel momento: non capii l’avvertimento, né lo fecero gli altri, eppure eravamo abituati ad ascoltare i rumori del buio, ci credevamo creature della notte e spesso parlavamo di andare a cacciare i gerboa, quei piccoli topi che fanno lunghi salti tra le pietre. Quale misterioso sortilegio rese torpide le nostre menti e sorde le nostre orecchie?
Dopo qualche minuto il villaggio lentamente riprese vita, i ragazzi cominciarono ad uscire dalle case e a raccogliere frettolosamente le borse che si portavano dietro, con un po’ d’acqua e qualcosa da mangiare, un pane, dei pezzi di formaggio, poi alla spicciolata scesero lungo la strada.
In certi momenti allucinati credo di ricordare che ero inquieta, mi pareva di avvertire sulla pelle una sensazione strana, come elettricità che mi facesse drizzare i peli. O forse è soltanto un sogno, un ricordo confuso, forse voglio illudermi di avere percepito qualcosa. Ma il puntino rosso lo vidi, ne sono sicura, lo vidi danzare un attimo sul muro scuro di una casa. Non capii cosa fosse, ma un anziano seguì il mio sguardo e si mise ad urlare.
Alcuni di quei maledetti si erano nascosti e avevano fatto allontanare le macchine. Adesso so che stavano puntando i loro fucili utilizzando dei mirini laser. In quel momento vidi i ragazzi che stavano passando nella piazza, diretti verso la strada, nitidi contro la terra bianca alla luce della luna.
Presa da un’ossessione mi alzai in piedi e urlai anch’io, sfuggendo alle mani di chi voleva fermarmi e correndo verso di loro, ma era troppo tardi: una serie di colpi aveva rotto il silenzio e vidi mio fratello Ahmed sollevarsi da terra sotto l’urto dei proiettili, fare un assurdo giro su se stesso e ripiombare giù come un mucchio di stracci.
Corsi fuori urlando, allo scoperto, mentre la gente cercava disperatamente di nascondersi.
Forse ero troppo piccola e veloce, certo un dio mi proteggeva, ma nessuna delle pallottole che fischiavano rabbiosamente attorno mi colpì nella mia folle corsa. Caddi, mi rialzai, caddi ancora ed avevo mani e ginocchia graffiate quando giunsi da mio fratello e mi inginocchiai vicino a lui. Il suo petto non esisteva più, era una massa di carne insanguinata. Gli occhi erano aperti, sbarrati dallo stupore, i capelli affondati nella terra. Non respirava. Gli sollevai il capo e lo strinsi a me con la poca forza che avevo, cercando di liberare i suoi riccioli scuri dalla polvere, cercando di cedere un po’ del mio calore alle sue mani che sentivo già raffreddarsi. E piansi, piansi, piansi fino a consumare tutte le lacrime che il mio piccolo corpo aveva dentro.
3.
Non so quanto tempo rimasi lì, nessuno venne a prendermi, immagino per paura che quelli fossero ancora in agguato. Non li sentii andare via, per me scese il buio e non rammento niente di quei momenti, o quelle ore.
Ricordo che una mano mi scosse, come per accertarsi che fossi ancora viva. Delicatamente mi tolsero il corpo di Ahmed dalle braccia e lo adagiarono su una lettiga improvvisata fatta con assi di legno, poi lo portarono via. Sentii mia madre che piangeva, gli altri miei fratelli che urlavano contro gli assassini, ormai lontani, senti il cane del deserto che ora ululava il suo richiamo, gli insetti che avevano ripreso a frinire. Ogni suono era amplificato, cresceva continuamente, diventava caos. Mi sembrava che la testa stesse per esplodere, sentivo la pressione dentro al mio cervello crescere , sempre di più. Mi presi il capo tra le mani e urlai con tutto il fiato che avevo in gola. D’improvviso scese il silenzio. Una luna immensa era sorta nel cielo, creando ombre spettrali sulla terra spaccata dall’arsura. Sentivo che qualcosa dentro di me saliva sempre di più, si stava rompendo. Pensai di stare morendo e mi lasciai cadere per terra, supina, mentre il cuore sembrava voler uscire dal petto. Respiravo affannosamente, non ero più capace di muovermi, riuscivo soltanto a guardare le stelle, desiderando di avere un po’ di pace, di dissolvermi nella morte.
La fortuna non volle accontentarmi e dopo un tempo che non so calcolare scivolai nel sonno, o svenni.
Mi risvegliai di colpo sotto il sole del mattino. Nessuno era venuto a cercarmi, o non mi avevano trovata. Mi alzai e cominciai a camminare verso il villaggio, senza voltarmi indietro. Mi rivedo con gli occhi di oggi, una figuretta nera, scalza, che camminava in silenzio, il volto rosso del sangue del fratello trucidato.
Raggiunsi i margini del villaggio, sorpassai il recinto di rovi che ne delimitava i margini e le prime case di fango e pietra. Camminavo senza sentire i sassi sotto i piedi, le braccia abbandonate lungo il corpo, sulla strada di terra battuta che conduceva al cuore della nostra piccola comunità. Mi fermai quando davanti a me c’era solo il deserto e mi ero lasciata alle spalle tutto quello che conoscevo. Mi sarebbe piaciuto pensare che guardando quel nulla sconfinato avessi maledetto gli assassini e la vigliaccheria della mia gente, e la mia inutilità, ma niente di tutto questo è vero: mi inginocchiai a terra, posai il capo nella polvere e piansi.
Seguirono giorni vuoti. Non riuscivo più a stare con le mie amiche e loro mi evitavano imbarazzate. Evitavo la piazza del villaggio dove Ahmed era stato ucciso, anche se ogni segno era stato fatto sparire, ma tutto era costruito intorno alla piazza, così non mi restava che andare ai margini e guardare verso la collina da cui erano partiti i colpi. Più di una volta mi arrampicai fino in cima, erano solo qualche centinaio di metri, a cercare i segni degli assassini, ma trovai solo tracce di ruote e erba schiacciata. Finì che mi limitai a guardare verso il deserto, persa in quella eternità immobile di terra e pietre. Sentivo il sole bruciarmi la pelle, il vento sabbioso scalfirmi il viso, i capelli farsi sempre più fini e secchi, poi cominciai a non sentire più niente e lentamente entrai in uno stato di comunione con quel mondo misterioso a cui sentivo ormai di appartenere. Non lo sapevo, ma mi stavo lasciando morire.
Alle mie spalle però c’era chi non si arrendeva e continuava a resistere: mia madre doveva soffrire ma anche combattere il suo dolore per continuare a crescere i suoi figli e mai pensò di abbandonarmi. Dopo aver invano tentato di rompere il mio isolamento e la mia muta disperazione cercando di parlarmi e poi di distrarmi nei modi in cui era capace, tentò di relegarmi in casa, ma era impossibile, in breve diventai abilissima a fuggire in tutti i modi possibili e per quanto venisse a riportarmi indietro io tornava sempre là, a fissare il nulla.
Alla fine mia madre rimase senza più risorse, ma non si arrese: andò al Centro durante una riunione degli anziani, passò dritta di fronte ai guardiani e irruppe in mezzo agli uomini, che la guardarono attoniti. Lì si strappò dal capo lo chador, lo gettò a terra e lo calpestò sotto i piedi. Agli uomini parlò con parole di fuoco: «Io vi rinnego» disse «rinnego voi che non sapete che starvene a parlare mentre mio figlio è morto e mia figlia vuole seguirlo, rinnego Allah che non ha saputo avere pietà di una madre e non vuole guidare neanche gli occhi di una bambina. Continuate a sedere mentre ci portano via il sangue e la linfa, mentre prosciugano le nostre vite come piante a cui è tolta l’acqua, continuate la vostra lenta morte!».
Dopo aver pronunciato queste parole che avevano lasciati esterrefatti gli uomini, estrasse dalla manica della sua tunica un lungo coltello ricurvo che si appoggiò alla gola.
«Bevi il mio sangue, Allah» disse «visto che di sangue ti pasci, del sangue dei tuoi figli!»
Con un rapido gesto fece per passarsi il coltello sulla gola, ma mentre quasi tutti la fissavano, inorriditi per la sua bestemmia, Khalid, uno degli anziani più vicino, si gettò su di lei, facendo sì che la lama incidesse la pelle ma non arrivasse all’arteria. Come fu rotta la magia di quel momento nel Centro scoppiò il finimondo, tutti che alzavano al voce commentando l’episodio e dicendo cosa si doveva fare, ma lo stesso Khalid, rialzatosi, fece segno ad uno degli uomini più giovani di prendere in braccio la donna svenuta e insieme la riportarono alla sua casa. Lì si fece dare dai vicini delle garze e del disinfettante e medicò la ferita, che non era profonda, quindi fermò l’emorragia con alcuni punti e finì la fasciatura con dei larghi cerotti, il tutto sotto gli occhi del marito e dei figli.
«Non credo che sia grave» disse «ma se le venisse la febbre o se avesse bisogno di qualcosa venite a chiamarmi». Poi venne a cercarmi.
Io ero nel mio solito posto, persa nel mio silenzio interiore. Percepii la presenza di Khalid non con la vista né con l’udito, ma con quel sesto senso che hanno gli animali del deserto, e così seppi che si era accovacciato vicino a me, in silenzio. Restammo coì a lungo, finché il sole non calò al nostro fianco e le ombre si allungarono fino a trasformarsi in lunghe mani ossute.
«Non sei colpevole di quello che è successo ad Ahmed» disse Khalid, rompendo il silenzio.
Mi voltai lentamente verso di lui, incapace di proferire parola.
«Sono stati i coloni ad ucciderlo, Shareefa, è contro di loro che devi rivolgere il tuo odio, non verso te stessa».
Ritornai a voltarmi verso il deserto. Tra poco i cani avrebbero cominciato a lanciare i loro ululati e gli uccelli avrebbero cantato al tramonto. Khalid si alzò senza più parlare e io non lo guardai allontanarsi.
Continuavo a fissare il nulla, ma qualcosa si era rotto dentro di me: adesso avevo un nemico da odiare, e pian piano cominciai a ritornare a vivere.
Arrivai al Centro ed entrai. Gli Anziani erano riuniti e stavano discutendo a voce bassa, certamente di quello che era accaduto il giorno precedente. Quando mi videro si zittirono, tutti sapevano quale era la mia condizione e si aspettavano una qualche scenata, solo Khalid pareva sorridere.
Mi diressi con decisione verso di lui, che era il capo del Consiglio e piegai un ginocchio a terra.
Lui mi fece cenno di alzarmi:
«Perché sei venuta da noi, Shareefa?» chiese con fare cerimonioso.
«Sono venuta ad arruolarmi» risposi.
L’Anziano scosse la testa.
«Hai solo otto anni».
«Se bastano per morire, allora bastano anche per combattere».
Gli uomini rimasero in silenzio alcuni istanti, poi Khalid si alzò dalla sua semplice sedia di legno, mi venne di fronte, prese la mia piccola mano tra le sue vecchie dita piegate dall’artrite e mi disse:
«Benvenuta tra noi, mujaheddin Shareefa».
Era la formula con cui venivano arruolati i combattenti. Khalid sapeva che avevo bisogno di avere una missione, uno scopo per riprendere a vivere, qualcosa che mi strappasse dall’ossessione di cui ero prigioniera e forse pensava che il tempo mi avrebbe fatto dimenticare quella frase, o forse no, ma io l’intesi in maniera molto chiara: la mia vita era cambiata per sempre.
Tornai a casa con la kefiah bianca e nera che mi avevano dato. Passai accanto ai miei genitori e ai miei fratelli che sedevano in silenzio nella casa buia. Nessuno aveva voglia di parlare. Mia madre si alzò, mi abbracciò, poi fece lo stesso gesto che aveva fatto quando ero ritornata sporca del sangue di Ahmed: prese uno straccio bagnato per pulirmi la faccia. L’allontanai con un braccio, bruscamente. Mio padre colse il gesto e vide la sciarpa, un oggetto che nella mia famiglia nessuno aveva mai portato. Un’ombra gli velò il viso ma non disse nulla, forse pensava che fosse solo il giocattolo di una bambina. Chinò però il capo, piegato dal presentimento che oltre ad un figlio quella sera aveva perduto anche una figlia.
4.
Nei giorni successivi nulla cambiò al di fuori di me, la vita nel villaggio continuò come faceva da generazioni, adattandosi alle situazioni che si presentavano e tirando avanti, con l’atavica rassegnazione dei poveri. Neanche in me sembrò cambiare molto: adesso avevo ripreso a mangiare ma tornavo sempre a passare le giornate di fronte al deserto, sola. Dentro però c’era stato un cambiamento radicale: non mi perdevo più nelle voci che portava il vento, ma sognavo, anzi, vedevo, carovane di uomini armati venirmi incontro e sfilarmi davanti, a volte in lunghe file di dromedari, altre, quando il rumore di una vettura rompeva il silenzio, in convogli motorizzati che sollevavano alte nubi di polvere rossastra.
A volte giungevano vicino a me le voci dei ragazzi che giocavano alla guerra, fingendo di essere veri combattenti. Loro mi ignoravano, ma non avevano il coraggio di prendermi in giro o infastidirmi: mi trattavano con l’imbarazzato rispetto che si tributa ai pazzi e mi sfilavano silenziosamente accanto.
Erano gli stessi ragazzi con cui avevo giocato sino a pochi giorni prima, e non ero certo meno scalmanata di loro, ma adesso li sentivo estranei nelle loro battaglie e soprattutto nella loro allegria. Non ne ero consapevole, ma le parole del vecchio Khalid mi avevano dato uno scopo per cui vivere ma non una strada per realizzarlo, per cui giorno dopo giorno sentivo la disperazione e il senso di colpa mordermi dentro con maggiore forza. Perché non ero morta io? era la muta domanda che mi ponevo, perché nella mia corsa per abbracciare Ahmed l’ultima volta le pallottole mi avevano risparmiato?
Lo so, adesso sarebbe facile rispondere che avevo un destino da compiere, ma una delle tante caratteristiche che differenzia i bambini dagli adulti è che i primi non riescono ad essere bugiardi con sé stessi.
Alla fine le voci che avevo dentro presero il sopravvento sulla calma che cercavo di mantenere esteriormente e non riuscii più a restare sola con me stessa, così ritornai al Centro dove si riuniva il consiglio degli anziani e mi sedetti a gambe incrociate vicino all’ingresso, osservando muta quelli che entravano e uscivano. Solo a sera mi alzavo e ritornavo a casa per mangiare, poi andavo a letto o, se il ricordo non mi concedeva di dormire, prendevo la mia coperta e andavo a coricarmi ai margini del villaggio, sotto la luna. La mattina poi ritornavo a sedermi all’ingresso del Centro.
Era chiaro che il mio comportamento doveva essere oggetto di discussioni, ma tutti passavano fingendo di non vedermi, sperando che mi stancassi. Non mi conoscevano, o meglio, conoscevano la Shareefa che esisteva prima di quel giorno maledetto in cui la mia infanzia si era interrotta per sempre
Un giorno, infine, Khalid si fermò vicino a me, si chinò sui calcagni e mi rivolse la parola:
«Shareefa» mi disse «tu non ti stanchi mai, vero?».
«No signore» risposi «io so aspettare».
Il vecchio sospirò.
«Domani verranno al villaggio dei reclutatori. Sceglieranno alcuni giovani da portare ai campi per l’addestramento. Io so che il tuo carattere è d’acciaio e il tuo odio brucia più del sole d’estate, ma per loro tu non sei altro che una bambina e non ti accetteranno mai. Però li conosco e so che sono uomini giusti: se dovessero trovarsi di fronte al fatto compiuto non ti rimanderanno indietro».
Dette queste parole si alzò se ne andò, e io rimasi lì, cercando di capire cosa avesse voluto suggerirmi.
L’indomani arrivarono davvero. Erano su due vetture e li seguiva un grosso camion a cui erano appesi dei fedayyn armati di kalashnikov che agitavano le armi in aria in segno di vittoria. Nel villaggio ci fu subito agitazione e i ragazzi corsero intorno ai guerriglieri per fare festa. Da una delle vetture scesero due uomini, uno grosso e barbuto e un altro magro e più piccolo, con un grande naso adunco, che furono accolti da uno degli anziani e sparirono con lui nella casa comune.
Fuori era finita la ressa intorno ai mezzi e adesso tutti si erano portati davanti all’ingresso, specialmente i ragazzi, curiosi di sapere cosa stessero dicendo e desiderosi di mettersi in mostra.
Dopo un tempo che mi sembrò lunghissimo gli uomini uscirono insieme a Khaled, che mi indicò. Il più piccolo si diresse verso di me.
«Shareefa» mi disse con gentilezza, come rivolgendosi ad una bambina «il saggio Khaled mi ha parlato di te, di quello che è successo e del tuo coraggio, e noi lo apprezziamo moltissimo, ma non possiamo portarti al nostro campo. La guerra non è fatta per le donne e tu oltretutto sei ancora una bambina. Ma verrà il momento di fare la tua parte, stanne sicura».
Poi mi fece un cenno di saluto e ritornò dagli altri.
Rimasi a guardarlo senza parlare. Il mondo mi era caduto addosso e non trovavo parole per protestare. E poi, chi ero io per mettere in discussione le decisioni dei capi?
Chi ero io? All’epoca non lo sapevo ancora, ma l’avrei imparato presto.
5.
Come ho detto, da quando avevano ammazzato mio fratello avevo cominciato a vagabondare per il villaggio e fuori dai suoi confini, al punto che nessuno faceva più caso a me. Anche i miei genitori, archiviato il dolore per Ahmed in qualche angolo del loro fatalistico modo di vivere e occupati con gli altri figli, che comunque erano maschi, avevano smesso di cercarmi e se non rientravo per mangiare e dormire non si preoccupavano più di tanto, sicuri che sarei tornata.
Trascorsi la notte in un angolo della piazza, rannicchiata in una zona d’ombra sotto una tettoia e in qualche modo mi addormentai. Mi svegliarono i primi raggi di sole e mi stirai nell’aria leggermente velata di foschia. Vidi il camion e le vetture, guardati da un uomo che era stato vinto dal sonno e dormiva appoggiato alla canna del fucile. Mi alzai e feci un giro intorno. Alcune balle di merce erano pronte ad essere caricate, qualche valigia e dei tappeti arrotolati erano stati messi sotto una delle panche del camion, una capra era legata al parafango. Cercando di essere più silenziosa possibile sgusciai sul mezzo e cercai un posto dove infilarmi. Stavo cominciando a disperare quando mi resi conto che i tappeti non riempivano completamente il vano. Ne spostai uno, mi ci infilai dietro e lo rimisi al suo posto. Ci stavo, lo spazio non era molto e probabilmente avrei patito il caldo, ma non sarei soffocata. Scesi di nascosto, andai a recuperare una fiasca d’acqua e ritornai al mio nascondiglio. Aspettai, da quel giorno maledetto la mia vita non era stata altro che attesa.
Non passò molto tempo che il villaggio cominciò a destarsi. Per prime uscirono le donne, con le giare sulla testa per andare a prendere l’acqua prima che il sole incendiasse la strada, quindi gli anziani che faticavano a dormire e infine tornarono i ragazzi che avevano lavorato a Gaza City, stravolti dalla stanchezza.
Udii sbattere le portiere e sentii degli scossoni far muovere il camion: gli uomini lo stavano caricando.
Trattenni il respiro, nel timore che spostassero i tappeti, ma nessuno si accorse di me, a parte la capra che era stata caricata per ultima e frugava incuriosita tra i miei piedi. La maledissi silenziosamente, ma per fortuna il suo agitarsi disturbò gli uomini, che la spinsero a calci sul fondo del cassone. Per ultimi salirono alcuni ragazzi del villaggio, molto meno chiassosi adesso che sapevano di andare a combattere davvero, lontani dalle loro famiglie.
Il viaggio fu lungo e massacrante. Per nascondermi meglio mi ero infilata tra i tappeti e il fondo del camion, e ad ogni scossone sulla strada sterrata il pavimento di metallo mi urtava sul fianco, mentre ero bloccata in quella specie di bara. Per fortuna entrava aria dalla fiancata scassata del mezzo, e avevo da bere, altrimenti non sarei riuscita a resistere fino alla fine del viaggio.
Ma arrivammo. Sentii il camion fermarsi al cancello d’ingresso del campo e gli uomini che si scambiavano le parole d’ordine, poi ripartì per percorrere alcuni chilometri e fermarsi ancora, stavolta definitivamente. Rumore di portiere, passi di persone che si alzavano e scendevano, grida.
Altri uomini arrivarono a scaricare, presero la capra, la merce, cominciarono a tirare fuori i tappeti. Trattenni il fiato.
«Ehi, Mohammed, guarda cosa c’è qui!»
Il tono della voce dell’ uomo era divertito, ma ciononostante la prima cosa che vidi quando misi fuori il naso dal mio nascondiglio fu la canna di un mitra. Mi levai lentamente in piedi, senza neanche pensare ad alzare le mani, mentre sempre più gente, accorsa dal richiamo, veniva a vedere.
Gli uomini adesso ridevano, indicandomi, mentre le poche donne mi guardano in silenzio. Il rumore alla fine richiamò anche il capo del campo, che era in una tenda insieme con gli uomini che avevo visto al mio villaggio. Mi indicò e scambiò qualche parola con l’uomo piccolo, che si mise a ridere, ma ero troppo lontana per capire cosa dicessero. Alla fine scoppiò in una risata anche lui, scosse la testa e tornò dentro.
L’uomo piccolo venne da me.
«Non ti arrendi facilmente, eh?» disse con voce seria. «I tuoi anziani me l’avevano detto, avrei dovuto stare più attento».
«Ma adesso» riprese «non possiamo certo rimandarti indietro, non abbiamo tempo da perdere. Vorrà dire che comincerai subito il tuo addestramento. In cucina, le donne saranno contente di avere un aiuto».
Nonostante la faccia dura i suoi occhi ridevano. Chinai la testa per ringraziare e in segno di rispetto, ma non dissi una parola.
Cominciarono così lunghi giorni in cui lavorai come non avevo mai fatto in vita mia: montagne di patate da pelare, lavare e tagliare a pezzetti, ortaggi da pulire, minestre da mescolare per ore, pane da impastare.
Non mi lamentai mai e pian piano le donne cominciarono ad apprezzarmi, anche se continuavo a parlare pochissimo.
Quando potevo, appena finito il lavoro, andavo nelle tende dove si insegnavano le arti della guerriglia, ma anche a leggere e scrivere, e mi sedevo in un angolino, avida di imparare. Alla sera, finito di lavare i piatti, mi accoccolavo vicino ai fuochi e ascoltavo gli uomini raccontare delle loro imprese, di guerra, di sangue, di fuoco, mentre la notte immensa del deserto scendeva ad abbracciarci comprensiva.
6.
In questo modo passarono i mesi e poi gli anni. Io crescevo d’età e di statura, anche se non molto, e tutti ormai erano abituati alla mia presenza e anche alle mie stranezze, che tolleravano per il mio passato e perché non mi tiravo mai indietro di fronte al lavoro, Ero piccola, ma avevo muscoli d’acciaio, forgiati dalla dura pratica quotidiana, e poco importava che portassi sacchi di farina o scavassi la latrina, i calli sulle mani erano gli stessi.
Un giorno mi trovavo in una tenda dove stavano insegnando la manutenzione le armi proprio mentre l’istruttore sgridava un ragazzo che non era stato attento e adesso faticava a rimontare il suo AK-47. Era una cosa che succedeva spesso perché a nessuno faceva piacere sporcarsi le mani con l’olio e ripetere gli stessi gesti migliaia di volte, fino ad imparare ad eseguirli ad occhi chiusi. Io, che ero esclusa da quell’attività, seguivo con avidità tutte le fasi, e quando l’istruttore si girò per vedere cosa stava facendo un’altra recluta levai l’arma dalle mani dell’allievo e la rimontai in un attimo. Ero stata rapidissima, ma il mio gesto non era sfuggito allo sguardo espero dell’uomo, che si voltò di scatto.
Mi guardò meglio, vide chi ero e si avvicinò.
«Ehi tu!» sbraitò, «fammi un po’ vedere come hai fatto!».
Tutti e due rimanemmo bloccati, poi il ragazzo si accinse a smontare nuovamente il mitra, ma quello lo fermò: «Non tu, lei!» fece, indicandomi.
Con le mani tremanti ma l’orgoglio nel cuore, smontai l’arma, gli mostrai i pezzi e la rimontai. Lui la prese in mano, la scosse per verificare che fosse montata correttamente, fece scattare alcune volte il grilletto ascoltandone il rumore netto e pulito e la restituì al ragazzo, poi riprese a seguire gli altri. Ci guardammo senza capire.
Cosa era successo lo compresi il giorno dopo. Finiti i soliti servizi in cucina stavo per uscire a godermi la serata quando trovai sulla porta l’istruttore, che mi fece cenno di seguirlo. Mi portò davanti ad una tenda sorvegliata da una guardia armata, che si spostò per farci passare.
«Ecco» disse «vista la tua passione per le armi qui avrai da divertirti. Mi aspetto di vederli come nuovi per la fine della serata».
Davanti a me, ammucchiati su di un tavolo, c’erano una decina di kalashnikov sporchi di terra e di olio, ancora odorosi di polvere da sparo. Mi rimboccai le maniche e mi misi al lavoro, conscia che quello era un vero e proprio esame. Smontai le armi, pulii le canne da ogni granello di polvere, le asciugai, le oliai, le rimontai, provai i meccanismi di scatto. Tutte, una ad una. Le guardai luccicare sul tavolo, poi, presa dalla paura di aver dimenticato qualcosa, rifeci tutto il lavoro da capo.
L’istruttore tornò che era notte fonda, osservò i mitra uno per uno, con attenzione, poi annuì soddisfatto.
«Ben fatto, Shareefa. Dalla qualità del tuo lavoro dipende la vita di chi va a combattere, perché un’arma che s’inceppa è una persona che muore, quindi non basta la buona volontà, ci vuole amore e paura di sbagliare. Sei assunta».
Da quel giorno cominciai a saltare dei turni in cucina per dedicarmi alla pulizia e al controllo delle armi, poi anche alla loro revisione. Per verificare eventuali problemi al sistema di puntamento ebbi l’occasione di frequentare il poligono e presto imparai a sparare meglio di tutti i maschi, perché sapevo correggere ogni imperfezione di mira.
Avevo già dodici anni, ero cresciuta e come premio cominciai a partecipare all’addestramento fisico, che consisteva soprattutto in lunghe corse ai confini del campo e combattimento a mani nude o con le armi bianche. In un primo tempo non mi fecero lottare contro i maschi – e tutti lì erano maschi – così mi allenai di nascosto con dei ragazzi che ne approfittavano per mettermi le mani addosso senza che potessi protestare. Questo mi permise di imparare a muovermi, ma gli uomini cominciarono a parlare tra loro e qualcuno si mise in testa idee sbagliate, così un giorno, mentre tornavo dal mio lavoro all’armeria sentii una sonora pacca sul sedere. Mi voltai di scatto e vidi uno di loro che rideva, insieme ad altri che sghignazzavano con lui.
«Hai poco da fare l’offesa» mi disse «lo sanno tutti che ti fai toccare dai ragazzi!».
«Maiale!» sibilai tra i denti, e i compagni dell’uomo si misero a ridere ancora più forte.
Questi, punto sul vivo, mi abbracciò e cercò di palparmi i seni, ma sbarrò gli occhi senza fiato quando il mio gomito si piantò nel suo plesso solare. Arretrai e gli diedi un calcio in faccia con i pesanti scarponi, poi, mentre ancora cadeva gli balzai alla gola e gli puntai il pugnale sulla carotide, premendo fino a far uscire qualche goccia di sangue. Il mio aggressore aveva la bocca aperta in cerca d’aria e non osava muovere un muscolo.
Sentii una mano appoggiarsi sulla mia e allontanare delicatamente il coltello dalla gola.
«Basta così, Shareefa, abbiamo visto tutto, lascia stare quell’imbecille e vieni con me».
Era Ansem Abi Al-Shaer ,il comandante del campo, stavolta ero davvero nei guai.
7.
Non ero mai entrata nella tenda del Comando, così mi guardai intorno incuriosita, ma a parte che era più grande del normale non vidi niente che facesse capire che lì si prendevano le decisioni più importanti. Il Comandante si sedette dietro una piccola scrivania e mi indicò una sedia pieghevole che era davanti, poi appoggiò i gomiti sul tavolo e mi guardò fisso negli occhi.
«Non credere che non sappia quello che stai facendo, Shareefa, non sarei al comando se non sapessi quello che succede nel mio campo. Sei come un gatto arrabbiato, cosa vuoi davvero?».
Non esitai un istante: «Vendetta, signor comandante».
«Lascia stare i titoli. So la tua storia, ma qui abbiamo tutti qualcuno da vendicare. Sono passati anni, probabilmente gli uomini che hanno assassinato tuo fratello saranno andati da qualche altra parte».
Scossi il capo.
«Gli agguati continuano, signore. Se quegli uomini hanno smesso ci saranno i loro figli o i loro amici».
Ansem rise.
«Va bene, Shareefa, voglio fare un patto. Noi abbiamo bisogno di te: una ragazza così minuta…» esitò, cercando le parole «una volta rimessa un po’ a posto passerà inosservata quasi dappertutto, e può aprire molte porte. Ti useremo per infiltrarti tra i nemici. Non ti nascondo che è un compito pericoloso, se verrai scoperta non avranno nessuna pietà perché ti considereranno una spia, ma tra un anno ti darò la possibilità di attuare la tua vendetta».
Fece una pausa: «Se sarai ancora viva» aggiunse.
Così fui promossa nelle truppe combattenti, e anche se non partecipavo ai raid ebbi la possibilità di frequentare l’addestramento vero e proprio e imparai l’uso di tutte le armi disponibili, degli esplosivi e di molti tipi di combattimento a mani nude. Feci tutto con il massimo impegno e fui sempre tra i primi dei corsi. Poi cominciarono le infiltrazioni, semplici ma via via più impegnative.
I servizi nemici cominciarono a domandarsi il perché di tante falle nei loro sistemi di sicurezza, e fui costretta a muovermi senza lasciare tracce né testimoni.
Tutto questo non durò un anno, ma quasi tre.
Nelle prime ore della mattina partivano i convogli per andare oltre frontiera, vecchi camion stracarichi di persone e merci, per lo più prodotti artigianali, che venivano venduti per pochi soldi ai commercianti delle città, i quali li rivendevano poi a prezzo decuplicato ai turisti che le guide portavano in giro per i bazar. Vendere direttamente ai turisti era proibito, si rischiava di essere arrestati e di avere la merce sequestrata, ma i poliziotti raramente avevano voglia di complicarsi la vita, preferivano riempire di bastonate la malcapitata e lasciarla sanguinante nella polvere. Le donne – erano tutte donne a fare quella vita – nonostante il rischio ci provavano sempre. Trovare dei turisti significava mettere da parte qualche soldo, e se venivano sorprese avevano imparato a non reagire: incassavano la testa nelle spalle, tenevano le braccia in grembo per evitare che qualche colpo rompesse delle ossa e aspettavano che finisse. Non so come facessero a vivere così, ma fame e disperazione possono molte cose. Io mi confondevo tra loro, un po’ ragazzina e un po’ donna, cercando di raccogliere le informazioni che servivano, e intanto imparavo e crescevo in età e in esperienza. Il mio fisico minuto e insignificante non mi consentiva di mischiarmi tra le entreneuse dei locali notturni, ma in compenso nessuno mi guardava due volte, e una sguattera può ascoltare tanto quanto una prostituta.
Negli intervalli, che via via si facevano sempre più lunghi, continuavo ad addestrarmi con gli altri, anche se non facevo parte di nessun gruppo. Scoprii che per gli uomini la guerra era quasi un gioco, mentre avevo già imparato sulla mia pelle che era tutta una maledetta assurdità, e che l’unica cosa importante era restare vivi. Non potevi commettere errori, discutere gli ordini o avere pietà.
D’altra parte io pietà non ne davo e non ne chiedevo. Conobbi dei ragazzi ed ebbi anche delle storie, quelle storie sospese, da soldati, brevi ed intense, che nascono quando si è fuori dal tempo, senza un futuro da costruire. Storie quasi d’amore, storie di sesso iniziate e finite sotto lo stesso cielo notturno, storie che avevano tutti e di cui nessuno parlava. In fondo eravamo tutti fantasmi che camminavamo, forse io ne ero solo più cosciente degli altri.
Parlavamo lingue diverse, loro fingevano combattimenti e sparavano su sagome o bersagli, io avevo già conosciuto l’odore del sangue..
Partecipavo alle esercitazioni come gli altri, soprattutto per non essere inattiva, ma ormai capitavano sempre più spesso incomprensioni, perché nonostante fossi più giovane avevo ormai molta più esperienza di loro. Ricordo che una volta l’obiettivo era quello di fare un’incursione in una installazione nemica: dovevamo neutralizzare le sentinelle, entrare nel perimetro della base e piazzare alcune finte cariche esplosive. Io facevo parte della squadra in avanscoperta e mi avvicinai strisciando ad uno degli uomini che faceva da sentinella – un nostro compagno che non sapeva nulla dell’attacco ed era di turno di guardia. Giunta alle sue spalle rimasi un attimo ferma per essere sicura che non mi avesse sentito, poi balzai avanti, gli misi una mano guantata sulla bocca e gli piantai un ginocchio nella schiena, facendolo inarcare all’indietro. Un attimo dopo il mio coltello premeva sulla sua gola. L’uomo era senza fiato, gli occhi sbarrati. Mi alzai in piedi, lasciandolo cadere a terra, e feci per proseguire. Gli altri si erano fermati e mi stavano guardando. Il capo missione si accertò che l’uomo non fosse ferito e venne verso di me:
«Shareefa, cosa ti prende?» mi chiese «è solo un’esercitazione!».
«Lo so» risposi «se non lo fosse quell’uomo sarebbe già morto: non mi lascio nemici vivi alle spalle!».
L’uomo mi guardò senza più parlare, scosse il capo e si avviò per continuare la missione, ma con molto meno entusiasmo.
8.
Quando non fu più possibile infiltrarmi perché la mia descrizione cominciava a girare, iniziai a partecipare a delle azioni sul campo, più che altro in ruoli di semtinella, perché erano riluttanti a mandare una donna a combattere ed io ero silenziosa come un gatto, ma capitò di essere intercettati e feci anch’io la mia parte, come gli altri.
Il tempo passava ma la situazione non cambiava mai: nei villaggi la miseria era sempre la stessa, le frontiere erano chiuse e la mia gente continuava a sopravvivere senza un futuro. Periodicamente si accendevano focolai di tensione, c’erano incursioni di elicotteri e tank nemici e allora ci nascondevamo di giorno nei tunnel sotterranei per uscire la notte e colpire. Le nostre azioni non avevano una vera efficacia militare, ma quella continua guerriglia li costringeva a tenere alta l’attenzione e rendeva poco economico occupare a lungo i territori.
Erano punture di spillo, ma gli spilli erano cannoni e missili, e il sangue che usciva non era mai una goccia soltanto. Con il susseguirsi delle azioni i comandanti cominciarono ad apprezzare la mia capacità di muovermi senza far rumore, di scivolare silenziosamente tra le linee nemiche, e così presero ad affidarmi il compito di andare in avanscoperta e preparare la strada alle incursioni. Svolsi quei compiti pericolosi con attenzione e indifferenza, e difficilmente il mio coltello tornava indietro senza essere macchiato di sangue. Quel sangue mi ricordava quello di mio fratello, e cominciai a prendere l’abitudine di sporcarmi il volto, dapprima inconsciamente, quasi in un rito, poi coscientemente. Ritornavo tra le nostre linee con la faccia dipinta di quel colore scuro, i miei occhi neri che brillavano alla luna, e i miei sapevano che la strada davanti era sgombra. Era nata Shareefa la rossa.
Un giorno Ansem mi mandò a chiamare e mi disse che era giunta la mia ora, finalmente.
Presi alcuni giorni per organizzarmi e partimmo in quattro, su una Toyota all’apparenza vecchia ma perfettamente funzionante.
Il problema principale era riuscire a capire quando sarebbe stata la notte buona, ma durante il mio lavoro di infiltrazione avevo fatto qualcosa anche in proprio e mi ero creata una piccola rete di amichette oltre frontiera. Curioso come fuori dalla Striscia il tempo passasse più lentamente: a quindici anni erano ancora ragazzine e parlavano, parlavano tanto. Troppo.
Viaggiammo di notte e arrivammo al villaggio di prima mattina. Approfittammo della tranquillità per girare sulle colline, ispezionare la zona dove si posizionavano gli assassini e studiare un piano d’azione.
Era essenziale simulare un incidente per evitare vendette sul villaggio: anche se nessuno ci avrebbe creduto il governo nemico non voleva innescare rivolte nella Striscia con azioni di ritorsione, non quando aveva altro da fare.
Entrammo nel villaggio senza farci notare. Io rimasi in disparte, il volto coperto dalla kefiah che mi faceva in parte anche da velo, e ci disponemmo in attesa. La giornata passò tranquilla e quando cominciò ad imbrunire uscimmo dall’abitato raggiungendo le posizioni che avevamo individuato, ma nessuno si fece vedere.
Fu la sesta notte che sentimmo arrivare i motori in lontananza. Ci affrettammo a sporcarci la faccia per mimetizzarci. I miei compagni usarono un po’ del fango vicino ai lavatoi. Io vidi una capra che era stata macellata secondo il rito e mi sporcai la faccia con il suo sangue, poi mi rimisi la kefiah e tornai dagli uomini.
Ci mettemmo in osservazione e vedemmo con i binocoli ad infrarosso i grossi motori diesel che si avvicinavano come fari nella notte.
Feci cenno agli altri di andare dove avevamo convenuto.
«Ricordatevi che uno lo voglio vivo» mi raccomandai.
Avevo scelto quegli uomini per la loro capacità di muoversi nella notte e li avevo studiati attentamente. Erano persone taciturne ma esperte, e sarebbero serviti per coprirmi le spalle nel caso qualcosa fosse andato storto.
Vedemmo le auto scure fermarsi in cima alla collina che sovrastava il villaggio, a poche centinaia di metri di distanza. La luna illuminava la terra spoglia mettendo in risalto i possibili bersagli. Alcuni uomini scesero rapidamente e andarono a stendersi sulla terra. Erano vestiti di nero, ma alcuni particolari, orologi, occhiali, riflettevano lampi di luce alla luna. Si sentivano sicuri. Ne contai quattro, poi udii il rombo dei motori che ripartivano e si allontanavano. Come quella notte maledetta scese il silenzio, e notai che gli animali del deserto continuavano a tacere, maledicendomi ancora una volta perché quella notte li avevo ignorati. Attesi ancora qualche minuto, poi diedi il comando con la ricetrasmittente e l’uomo che avevo lasciato al villaggio cominciò a far muover le sagome che avevamo predisposto per creare una diversione e attirare l’attenzione degli assassini. Con un gesto feci cenno ad un compagno di avanzare con me e arrivammo a pochi passi dagli uomini in agguato. Restammo in silenzio, immobili.
Ad un tratto uno cominciò a sparare, due, tre colpi secchi. Dal villaggio giunsero delle grida, e anche gli altri fecero fuoco. Io e il mio compagno eravamo giunti alle spalle dei nemici appostati alle ali dello schieramento. Senza fare rumore strisciai fino ad arrivare al fianco di quello di destra, gli passai intorno al collo la sottile corda d’acciaio e tirai con forza, tagliandogli la gola e facendolo soffocare nel suo sangue, poi balzai sull’altro che si era alzato sentendo il rumore e non gli lascia il tempo di capire costa stava succedendo. Lo tramortii colpendolo con il calcio del mitra in faccia, lo disarmai e gli legai i polsi con delle fasctette di plastica. Il quarto uomo nel frattempo era già morto, il mio compagno non aveva ordine di fare prigionieri. Quando sentii il suo fischio estrassi dal fodero del coltello lo spillone d’acciaio che il guerrigliero venuto dal Sudafrica mi aveva insegnato ad usare e lo infilai con forza nella colonna vertebrale del mio prigioniero, paralizzandolo, poi ci disponemmo ad aspettare nella notte tornata silenziosa.
Non passò molto che sentimmo i veicoli che venivano a recuperare i loro compagni che avevano finito di fare il tiro al bersaglio. Erano due grosse Chrysler nere che procedevano sulla strada sterrata alla massima velocità consentita dal buio. I fari sobbalzavano nella notte, proiettando i fasci luminosi ora sulla terra ora in cielo. Dovevano essere allegri.
Arrivarono sulla spianata in cima alla collina e rimasero interdetti quando videro che i loro amici non si muovevano, ma in quel momento si scatenò l’inferno. La KPV da 14,5 mm cominciò a vomitare una valanga di fuoco ed in pochi istanti tutto fu finito.
Io e il mio compagno trascinammo i morti e il superstite contro le carcasse dei veicoli, poi gli feci cenno di aspettarmi più avanti. Presi una latta di benzina e la versai sopra a tutto, uomini e veicoli, stando attenta a non lasciare nulla di asciutto. L’odore acre fece riprendere i sensi a quello che avevo catturato vivo, che cominciò a lamentarsi. In quel momento la luna uscì dalle nuvole e illuminò il suo volto: era soltanto un ragazzo, poco più grande dell’età che aveva mio fratello Ahmed quando era stato assassinato. Anche lui mi vide in volto, sentì l’odore della benzina e capì cosa stavo per fare. I suoi occhi mi fissarono terrorizzati, e in quel momento capii che davanti alla morte siamo tutti uguali.
«No… no… ti prego» biascicò con la voce impastata dal sangue che gli colava dalla bocca spaccata dal mio colpo.
Ecco, forse in quel momento, solo in quel momento, vedendo il suo sguardo, mi trovai davanti ad un bivio che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Ma accesi il fiammifero che tenevo in mano e lo lancia sul mucchio.
Mi allontanai senza voltarmi indietro mentre la notte veniva illuminata a giorno dal falò, ed avevamo appena cominciato a scendere dalla collina che le gomme cominciarono ad esplodere.
Televisione e giornali raccontarono che due vetture erano saltate su una mina anticarro e sei escursionisti erano morti nell’incidente, mettendo in guardia i cittadini dai pericoli della Striscia.
9.
I giorni successivi furono strani. Compiuta la vendetta mi rimase dentro un grande senso di vuoto, una stanchezza che non voleva passare in nessuna maniera. Sentivo di non avere più scopi, motivazioni, che la mia vita era finita quella notte in cui tenevo tra le braccia mio fratello e che il resto era stata solo una lunga, lunghissima agonia. Alla fine venne a prendermi il comandante Ansem e mi parlò a lungo, della guerra, del nostro futuro, della miseria del nostro popolo. Sarei bugiarda se dicessi di ricordare una sola di quelle parole, ma alla fine mi disse:
«Shareefa, quando ti sentirai pronta avremo bisogno di te».
Mi riscossi di colpo e risposi meccanicamente:
«Agli ordini, comandante. Sono pronta».
Cominciarono anni di combattimenti, missioni nella Striscia e poi fuori, lontano, dove erano i nostri alleati. Anni di sangue, esplosioni, odore di cordite e di olio lubrificante, raid notturni, armi sempre più sofisticate e tremende, morti, sempre più morti. Prima di partire mi tingevo la faccia col sangue e portavo la kefiah come un velo, in modo che soltanto i miei occhi fossero visibili. Col tempo altri presero ad imitarmi e così nacque la leggenda della Rossa, anche se avrei dovuto vivere cento vite per essere in tutti quei posti, a volte contemporaneamente.
So che prima o poi qualcosa andrà storto e che rimarrò anche io in un campo tra il sangue, ma non me ne preoccupo: tutti moriremo e quella morte non è peggiore delle altre. Ho smesso di avere paura quando sono morta la prima volta e quando sarà il momento me ne andrò senza chiedere aiuto a nessuno, come ho sempre vissuto.
E adesso, giornalista che vieni dall’Europa, adesso che ti ho raccontato la mia storia, posa il tuo registratore e la macchina fotografica. Raccogli dal fuoco un kebab e assaggia il gusto della carne e del sangue, senti il profumo che sale acre tra il fumo, ascolta gli animali del deserto che si avvicinano per aspettare i nostri avanzi. La luna è alta nel cielo e la notte è dolce e bellissima.
Domani verrà e tu tornerai nella tua città, mentre io aspetterò un’altra missione, e un’altra, e un’altra ancora. Vai e racconta la storia della Rossa, forse qualcuno alla fine ci vedrà quella morale che io non ho mai trovato.
E fu proprio sul limite del villaggio, a un passo dalle pietre che ancora lo cingevano, che Shareefa infine si fermò. Al di qua delle rocce un paese stremato da una secolare miseria. Oltre, il deserto.
La donna si chinò a raccogliere una manciata di sabbia nel pugno, lo portò davanti agli occhi del vecchio seduto sulla panchina di granito e cominciò a lasciare scivolare i granelli tra le dita.
«Vedi, Khaled, come il tempo ci sfugge di mano giorno dopo giorno? Come questi granelli di sabbia che ho tolto al deserto e ad esso ritornano. Così siamo noi, così sono io».
L’uomo non rispose, lo sguardo cieco perso nell’infinito.
Shareefa si alzò.
«Non avrei mai creduto di arrivare viva a questa età. Ho combattuto da quando ero una bambina e ho sparso molto più sangue di quello che mi era stato tolto, ma la vendetta è una belva che non è mai sazia. Sono una figlia del deserto, lì ho imparato a vivere e lì farò ritorno».
Detto questo, si voltò verso l’oceano di sabbia e restò alcuni istanti ad ascoltare il sibilo del vento che sollevava nuvole di polvere sulle dune, come a cercare la voce che sembrava chiamarla, poi fece un passo oltre la linea delle pietre e si addentrò nel deserto lasciando piccole impronte che il vento subito copriva.
Il vecchio osservò la sua ombra allontanarsi, il kalashnikov e le cartucciere a tracolla, le bisacce d’acqua sulla spalla, la mimetica sbiadita, gli stivali.
Se ne andava come era venuta, tanti anni prima: il deserto dava e il deserto riprendeva, come sempre,
Con un gesto della mano rinsecchita calò un lembo della kefiah sugli occhi e lentamente si addormentò nella calura della sera.
<<<<>>>>