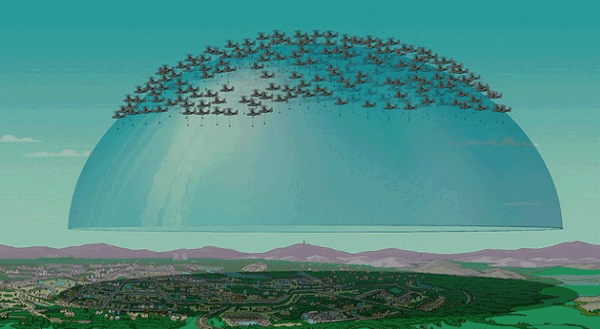Verdi e trasudanti umidità, le colline di Forest Park correvano ad ovest di Portland disegnando una linea sghemba che separava la città dai più alti contrafforti della National Forest, e oltre, l’oceano. Il fitto muro vegetale di abeti Douglas si snodava sinuoso lungo la dorsale delle colline, alla cui base, nei tratti più ripidi, il perimetro era tratteggiato da una colonna di rocce di basalto.
Phoebe e Jack arrancavano a causa della ripida salita, e il terreno limoso che smottava di continuo sotto i loro piedi li costringeva a piantarli con forza nel fango per non scivolare.
A differenza di Jack, più pesante e lento, Phoebe, esile e leggera, avanzava con minor sforzo apparente.
I capelli biondi legati in una coda di cavallo, la maglietta rosa e il giubbino jeans legato sui fianchi, le conferivano ancora l’aspetto di adolescente, smentendo i suoi anni. Ogni tanto si voltava indietro a guardarlo e a sfotterlo, perché lo immaginava inveire in silenzio contro sé stesso per averle proposto quell’escursione che s’era rivelata più ostica del previsto.
«Ce la fa dottor Longshire? La vetta è ancora lontana».
«Posso chiedere di essere esonerato da questa impresa, generale Newell?».
«Fuori discussione, dottor Longshire. Piuttosto, smuova quel suo grasso culo e si dia da fare».
Lungo il percorso Jack vide a lato del sentiero un legno solido e smussato che poteva fungere da bastone. Si chinò per raccoglierlo, quando sentì gridare: “Attento!”.
D’istinto ritrasse la mano prima che la frustata della coda dello scorpione lo colpisse col suo veleno.
«Maledizione!» inveì scartando di lato e ponendo la maggiore distanza possibile tra lui e la bestia.
A quell’esclamazione, Phoebe, che lo aveva preceduto per un breve tratto nella salita, si voltò e lo vide guardarsi intorno con aria smarrita.
«Jack… Jack… stai bene?» chiese preoccupata, tornando indietro.
«Dove è andato?».
«Di chi parli?».
«Dell’uomo che mi ha avvertito della presenza dello scorpione. Credo dovesse essere là». Indicò con la mano il punto dove aveva trovato il bastone.
«Ma non c’è nessun altro oltre noi su questo sentiero».
«Eppure ho chiaramente sentito il suo avvertimento».
Il tono, però, ora era incerto. Dubbioso.
«Se ci fosse stato lo avrei visto e sentito anch’io. A meno che non si tratti dell’uomo ombra o del tuo spirito guida, visto che siamo nel territorio degli Yakama» provò a sdrammatizzare la ragazza, prendendolo sottobraccio e stringendosi a lui.
Era questo che gli piaceva di Phoebe, il modo in cui affrontava le cose, col buon senso e l’ironia. Aveva ragione, se ci fosse stato qualcun altro lo avrebbe visto e sentito. Era stata solo una suggestione, quel grido, generato dalla sorpresa e dalla paura.
Scosse le spalle e riprese la salita. Concentrato sulle difficoltà del percorso non pensò più alla sua brutta avventura.
Giunti in cima, ansanti ed accaldati, sedettero nell’erba alta a riprendere fiato e a godersi lo spettacolo di quel cielo terso, quasi primaverile, nonostante fosse ottobre inoltrato. Phoebe, distesa accanto a lui, aveva chiuso gli occhi e sembrava dormisse. Jack si girò sul fianco a guardarla e lei, conscia di quello sguardo, gli sorrise. La bocca con gli angoli rivolti verso l’alto le conferiva un’espressione serena, ottimista, accentuata dagli occhi non grandi ma di un azzurro così vivido da risaltare come la nota predominante nel suo volto.
«Che c’è?».
«C’è che sei bella, ed io sono un uomo fortunato» rispose, carezzandole il viso con un filo d’erba.
Phoebe aprì gli occhi e lo attirò a sé baciandolo. Rotolarono sull’erba ridendo, stuzzicandosi e lasciandosi andare ad effusioni sempre più intime. Fecero sesso con passione, poi, appagati, rimasero abbracciati in silenzio.
Jack si sentiva in forma, nonostante il fisico appesantito da qualche chilo di troppo, e ben disposto verso l’intero universo. Phoebe riposava quieta tra le sue braccia mentre lui, felice di quel momento perfetto, era pervaso da un sentimento profondo di amore e di gratitudine per quello che lei era e rappresentava. La consapevolezza del valore di Phoebe e del ruolo primario che lei occupava nella sua vita lo avevano indotto a considerare l’idea del matrimonio, e non perché lei gli avesse mai fatto pressioni o quello fosse l’inevitabile epilogo di un rapporto che si protraeva da tanti anni, ma perché gli sembrava fosse giunto il tempo di arricchirlo con progetti ed obiettivi a più largo raggio. Metter su famiglia, come si diceva un tempo.
Coetanei ed entrambi di Portland, si erano però conosciuti ad Harvard, dove lei, Phobe Caroline Newell, figlia di un produttore vinicolo e con la prospettiva di subentrare nell’azienda di famiglia, stava completando la sua laurea in Economia e Commercio con un Master Business Administration e lui, Jack Longshire aveva appena conseguito la specializzazione in Molecular and Cellular Biology. A farli conoscere fu Susan Ross, la sua fidanzata di allora e compagna di stanza di Phoebe. Per Jack fu un colpo di fulmine, s’innamorò all’istante di quella ragazza bionda, minuta, dagli occhi turchini e dalla spiccata personalità. Un rapporto solido, basato sulla complicità e l’indipendenza, ma che ora Jack, sulla soglia dei quarant’anni, sentiva il bisogno di definire e perfezionare con un figlio, e su questa prospettiva sentiva il bisogno di accelerare i tempi. Si era ripromesso di parlarne quanto prima con Phoebe, seppure nutrisse dubbi su come l’avrebbe presa, perché lei non aveva mai espresso l’esigenza di un cambiamento e tanto meno quella di diventare madre. Ma forse non era il momento adatto, pensò, guardandola aprire gli occhi, sorridergli e stiracchiarsi soddisfatta. Come Adamo ed Eva, avevano fatto l’amore con passione in quel paradiso terrestre, e così quella sua proposta, che forse avrebbe creato qualche attrito, sarebbe stata inopportuna e avrebbe rovinato tutto.
«Come mai così pensieroso?» chiese Phoebe, mentre si annodava i capelli in una coda di cavallo. Per tutta risposta lui la baciò e l’attirò di nuovo a sé nel letto d’erba.
«Ehi, pigrone, è ora di rimettersi in marcia o ci coglierà il buio» lo sollecitò Phoebe, già pronta per riprendere il cammino. Jack, guardò l’orologio e poi il cielo che aveva assunto toni di un blu polveroso, mentre il sole, perdendo d’intensità, iniziava a scolorirsi in un pallido avorio. Presto sarebbe scesa la sera e avrebbe iniziato a far freddo.
«Possiamo contattare la guardia forestale» propose Phoebe, cavando di tasca il suo hi – phone. Cercò il numero su Google, ma l’assenza di campo la fece desistere.
Anche Jack provò col suo, ma senza successo.
“C’è una scorciatoia a nord, proprio dietro il magazzino degli Yakama. È un breve ripido pendio vietato agli escursionisti perché immette direttamente sulla statale. Il terreno però è solido e ci sono appigli vegetali che facilitano la discesa. Praticabile, con le dovute attenzioni”.
Memore della reazione di Phoebe, Jack, anche se colto di sorpresa da questa nuova entrata in scena della voce, s’impedì qualsiasi reazione, limitandosi a cercare intorno con fuggevoli sguardi. Ma come era già accaduto quella mattina, quando grazie al misterioso avvertimento era scampato al veleno dello scorpione, non vide nessuno. Non aveva alcun indizio per scoprire da quale parte scaturisse quella voce che Phoebe sembrava non udire. Doveva decidere rapidamente se ignorare o assecondare quel consiglio che gli giungeva da chissà dove. Anche se chi gli aveva dato il suggerimento sembrava sapesse il fatto suo.
«Ci siamo persi?» chiese perplessa, seguendo la direzione del suo sguardo.
«No» la rassicurò Jack, mascherando con un tono neutro la sua tensione emotiva «stavo valutando se prendere la scorciatoia che immette sulla statale, dietro il capannone degli Yakama. Saremo fuori dal parco prima che faccia buio».
«Come fai a conoscerla? Sei già stato qui?»
«Sì, da ragazzino, quando ero nei boy scout» mentì lui.
Quell’affermazione era una bugia… ovvero, una mezza bugia, perché nei boy scout c’era stato davvero ma non conosceva nessuna scorciatoia a Forest Park.
S’incamminarono verso nord e presto trovarono la rimessa indiana, una costruzione parzialmente diroccata, un tempo magazzino per i commerci delle pellicce e dei salmoni affumicati.
Dietro la costruzione un’alta rete di metallo arrugginito circoscriveva l’intero perimetro, impedendo l’accesso al pendio. Diversi cartelli ammonivano sui pericoli dello scavalcamento e sulle sanzioni in cui si sarebbe incorsi in caso di trasgressione.
Phoebe, alla vista del declivio, istintivamente si ritrasse.
«Ma come diavolo pensi di scavalcare la rete e poi affrontare la discesa?» domandò stupita e delusa.
«Il pendio è ripido ma breve, il terreno è solido e non mancano appigli a cui sostenersi».
Era vero. La discesa non era solo terra, ma c’erano alberelli e cespugli a cui aggrapparsi, e costole di roccia a far da gradino.
“C’è un varco, ben mimetizzato, nella parte destra della rete, lei ci passa agevolmente ma tu dovrai fare qualche acrobazia” suggerì la voce. In effetti c’era uno strappo nel reticolato, segno del passaggio di altri, abbastanza ampio da consentire l’accesso, anche se difficoltoso per un uomo di medie proporzioni.
Jack lo mostrò a Phoebe.
«È della tua misura» tentò di scherzare.
Lei non rise della battuta ma passò dall’altra parte senza troppe difficoltà, mentre Jack dovette forzare con le spalle e con le mani. Alla fine guadagnò l’uscita con qualche graffio e diversi strappi nella giacca a vento.
Per la discesa individuò la parte del versante più fittamente ricoperta di vegetazione.
«Togliamoci le giacche saremo più liberi nei movimenti» propose Phoebe legandosi il giubbetto jeans in vita. Jack, invece, si liberò della sua giacca a vento lanciandola oltre la rete, in direzione del magazzino Yakama.
«Per evitare che si pensi ad un suicidio» provò di nuovo a scherzare. Ma stavolta non rise neppure lui.
Solo un guardrail delimitava le pendici del declivio dalla statale, un’esigua striscia di terra ruvida.
Una volta discesi Jack e Phoebe si trovarono incanalati in quello stretto budello e dovettero procedere in fila indiana.
Era già quasi buio e iniziava a far freddo. Jack non aveva più la sua giacca a vento ma solo una t-shirt a manica corta. Per solidarietà Phoebe non aveva messo il giubbino jeans, ma quando Jack se ne avvide la esortò ad indossarlo. Lei oppose qualche resistenza perché si sentiva in colpa ad averlo indotto a disfarsi della sua giacca come di un ingombro, ma lui la rassicurò che non sentiva poi così freddo. Un disagio solo momentaneo, perché presto sarebbero stati al riparo della loro auto, parcheggiata all’ingresso del parco. Esattamente nel punto opposto da dove erano discesi. Questo significava una lunga camminata, con la stanchezza che iniziava a farsi sentire, mentre le macchine, che sfrecciavano a pochi centimetri da loro, acuivano la sensazione di precarietà che li aveva accompagnati durante la discesa, che, ad onore del vero, s’era rivelata meno difficoltosa del previsto. Camminavano in silenzio, Phoebe avanti e lui dietro, e questo gli diede modo di soffermarsi a riflettere su quello che gli stava accadendo.
A chi apparteneva la voce che l’aveva salvato dallo scorpione e poi gli aveva mostrato quella scorciatoia?
Una voce amica, a quanto pareva. Ma di chi? Magari quella del suo angelo custode. Jack sorrise scettico a quell’ipotesi: era credente, ma non fino a quel punto. Forse era la voce di suo padre, deceduto parecchi anni prima, ma il timbro era decisamente diverso. E se invece avesse sviluppato doti di preveggenza? Il famoso sesto senso, il formidabile intuito che capta le situazioni di pericolo. Questa ipotesi era quella che gli piaceva di più perché escludeva interventi esterni e riconduceva tutto a sé stesso. Alla sua mente.
Phoebe, quasi avesse letto i suoi pensieri, si voltò a guardarlo e gli sorrise. Era stanca, lo si capiva dal viso e dal passo che aveva perso d’elasticità.
«Coraggio. Manca davvero poco» la confortò Jack.
Lei annuì e tornò a guardare davanti a sé.
“Tutto avviene nella mia testa” stabilì Jack riprendendo il filo delle sue riflessioni. La luce abbagliante dei fari di un’auto che procedeva contromano e a velocità sostenuta lo colpì in pieno negli occhi, facendolo per un momento vacillare. Il coro frastornante dei clacson si propagò, frantumandosi in milioni di eco che andavano infiggendosi, come acuminate punte di vetro, nel suo cervello. Uno dei suoi lancinanti mal di testa. Si portò le mani alle orecchie e chiuse gli occhi. Quando li riaprì il flusso delle macchine scorreva ordinato e Phoebe camminava avanti a lui come se nulla fosse accaduto. L’indomani ne avrebbe parlato con Nathan Cooper, il suo amico neurochirurgo.
Giunti alla fine del viottolo che portava davanti all’ingresso della casa di Phoebe, Jack fermò la macchina e fece il gesto di scendere per andare ad aprirle la portiera, ma lei era già sul marciapiede.
«Ci vediamo domani sera?».
Phoebe scosse la testa: «No, la prossima settimana sarò fuori Portland per impegni di lavoro. Ci vediamo sabato, va bene?».
«Sabato sono stato invitato al Green Hill Country Club. Ti va di farmi compagnia?».
«Ok» acconsentì Phoebe baciandolo, e senza dargli il tempo di aggiungere altro, corse verso il portone.
Jack mise in moto e fece manovra nell’esiguo spazio in fondo alla strada per tornare a casa. Era sfinito. Soprattutto avrebbe voluto smettere di pensare. Guardò l’orologio sul cruscotto: le ventidue. Se solo avesse potuto tornare indietro di ventiquattro ore e cancellare la gita a Forest Park…